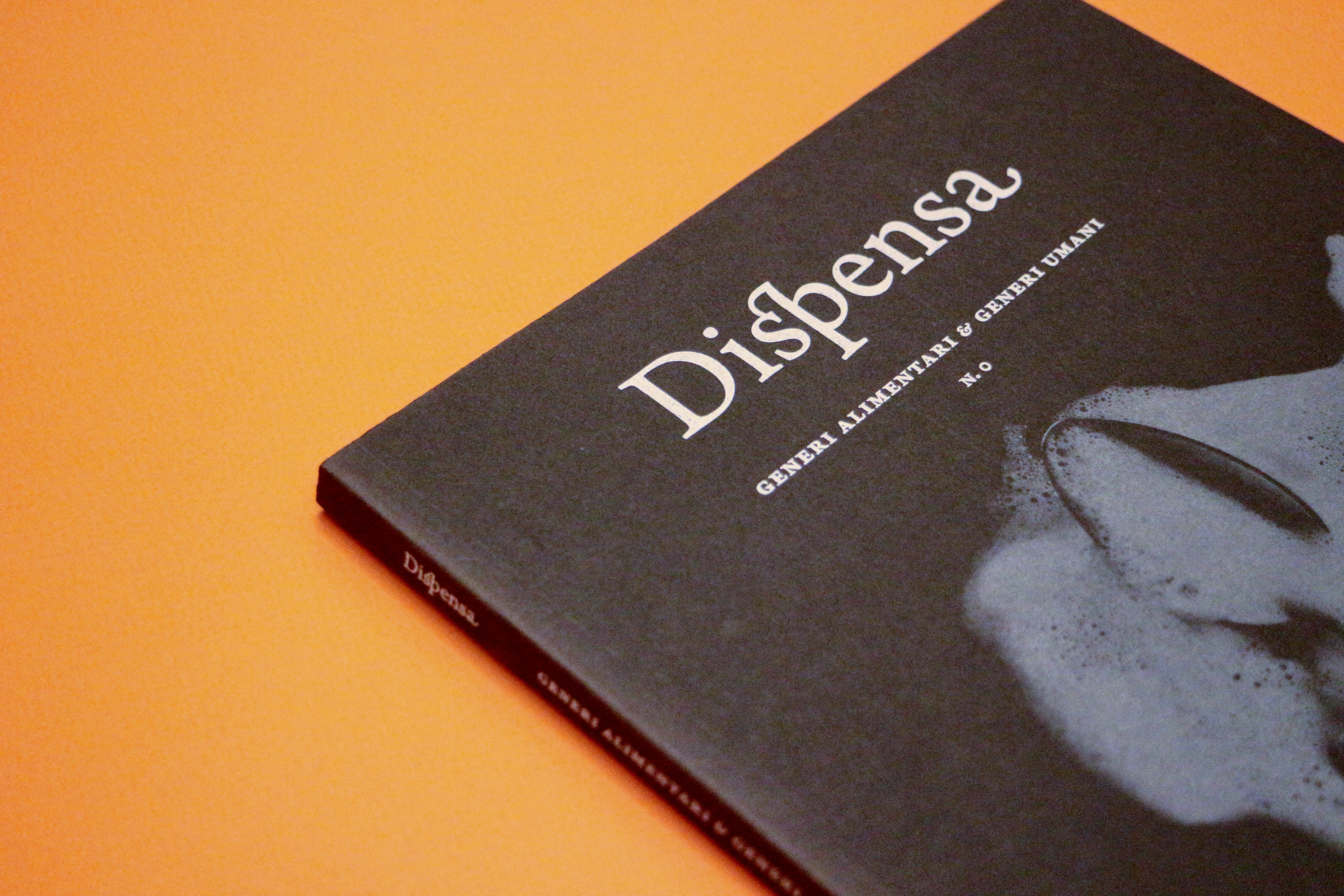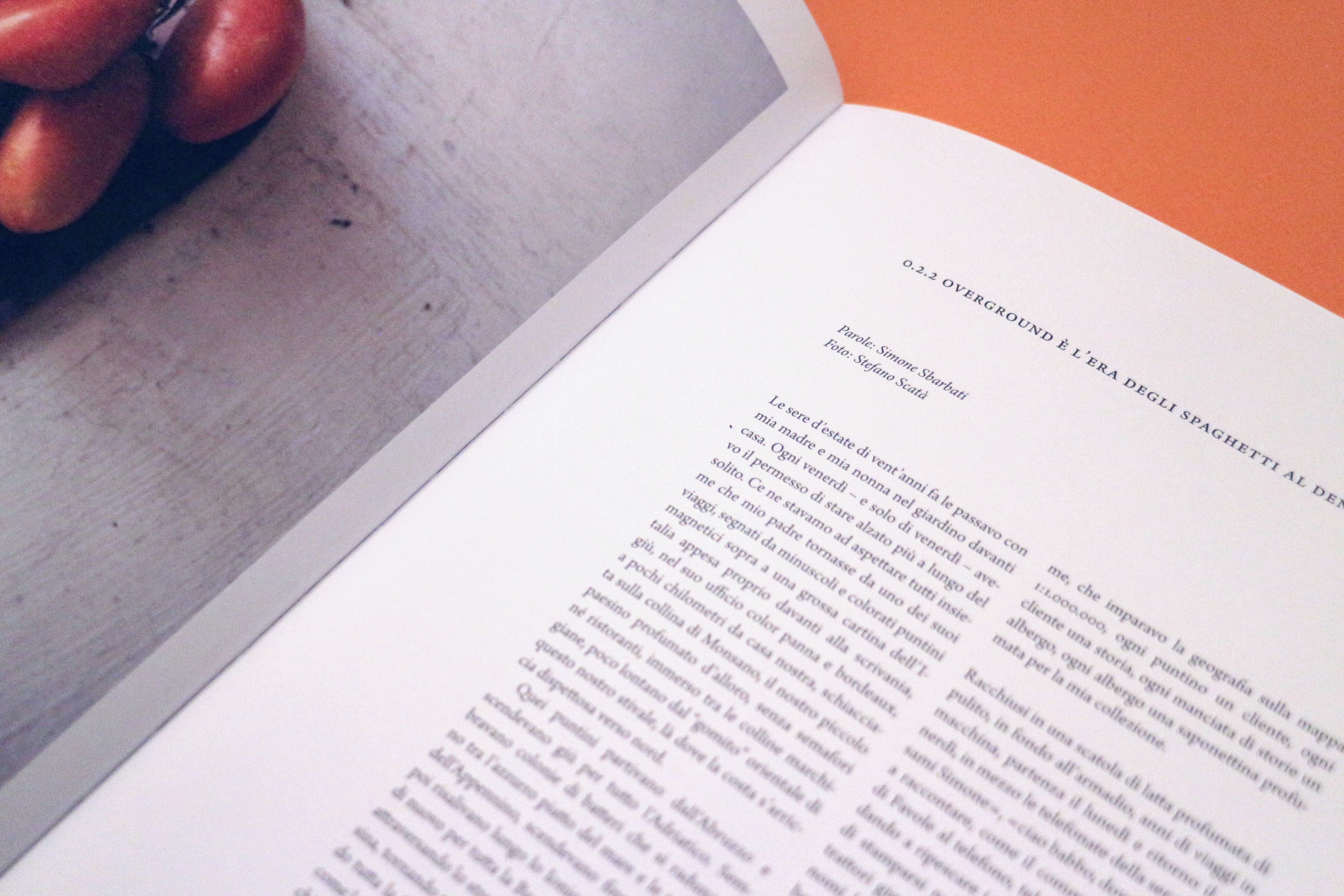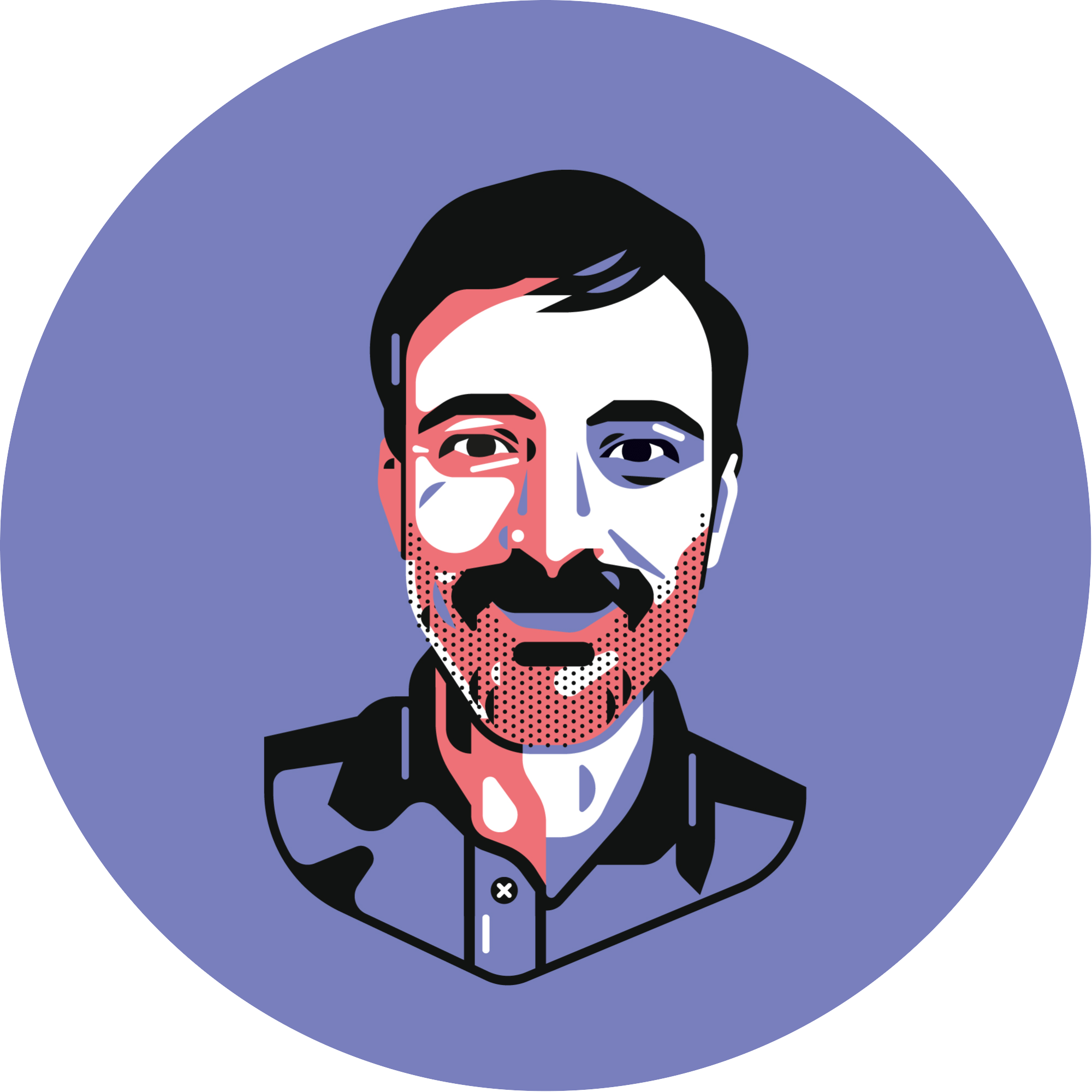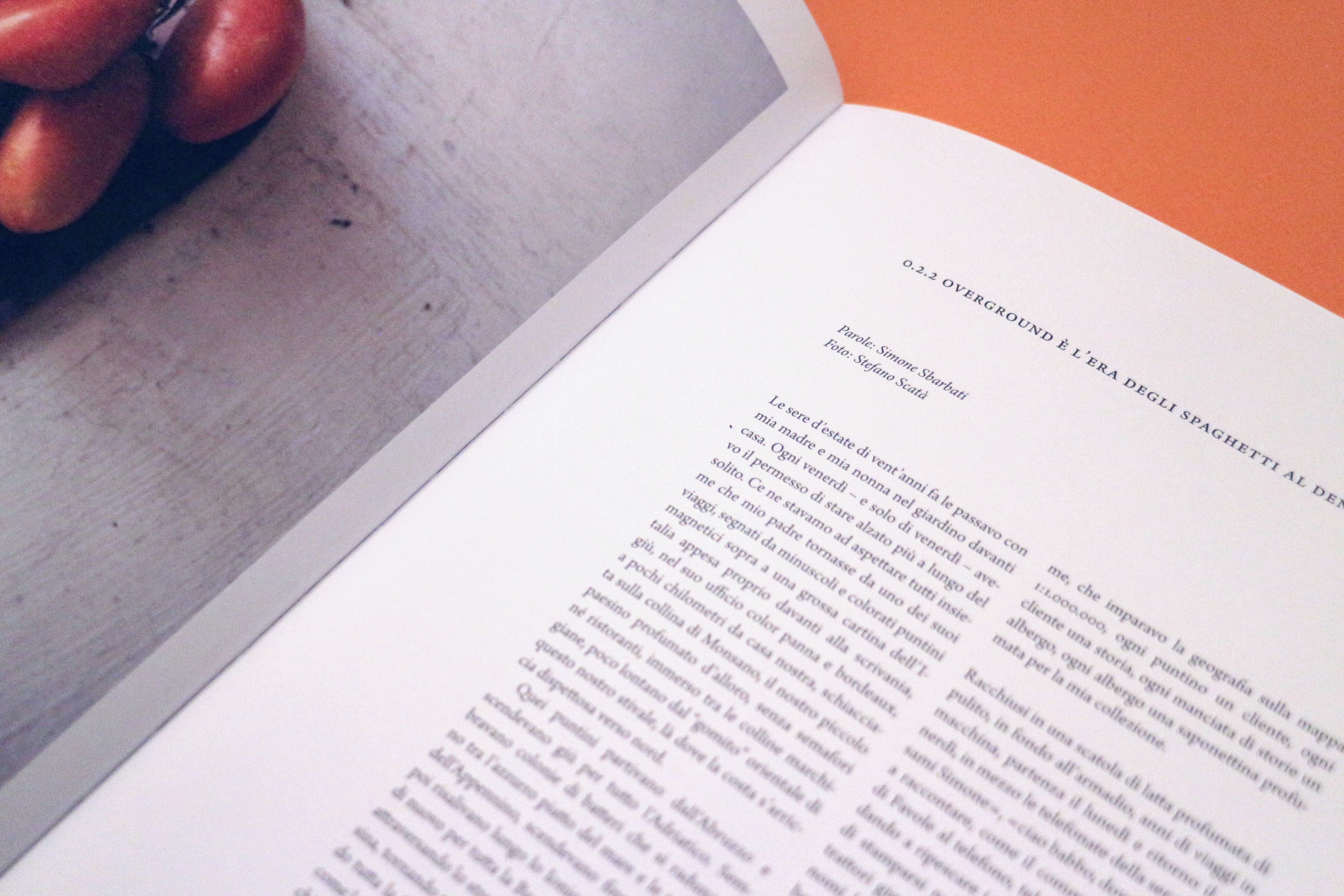
Dispensa nº0
maggio 2013
Fondata da Martina Liverani, Dispensa è una rivista di “generi alimentari & generi umani”, dedicata al cibo e all'universo che gli gira intorno.
Un magazine indipendente per chi non ha fretta, basato su long form e splendide fotografie.
Il mio pezzo — che si può anche ascoltare in podcast, letto meravigliosamente da Massimiliano Rossi — è accompagnato dalle foto di Stefano Scatà e parla di ricordi, pomodori freschi e spaghetti al dente.
direttore responsabile • Martina Liverani
art direction e impaginazione • Unknown studio
foto di copertina • Lee Anouchinsky
Overground è l'era degli spaghetti al dente
Le sere d'estate di vent'anni fa le passavo con mia madre e mia nonna nel giardino davanti casa. Ogni venerdì — e solo di venerdì — avevo il permesso di stare alzato più a lungo del solito. Ce ne stavamo ad aspettare tutti insieme che mio padre tornasse da uno dei suoi viaggi, segnati da minuscoli e colorati puntini magnetici sopra a una grossa cartina dell'Italia appesa proprio davanti alla scrivania, giù, nel suo ufficio color panna e bordeaux, a pochi chilometri da casa nostra, schiacciata sulla collina di Monsano, il nostro piccolo paesino profumato d'alloro, senza semafori né ristoranti, immerso tra le colline marchigiane, poco lontano dal “gomito” orientale di questo nostro stivale, là dove la cosata s'arriccia dispettosa verso nord.
Quei puntini partivano dall'Abruzzo e scendevano giù per tutto l'Adriatico. Sembravano colonie di batteri che si radunavano tra l'azzurro piatto del mare e le rugosità dell'Appennino, scendevano fino al tacco e poi risalivano lungo lo Ionio e si allargavano di nuovo per tutta la Basilicata e la Calabria, attraversando lo stretto fino a Catania e Messina, tornando poi sul Continente, riempiendo tutta la Campania e raggiungendo chissà come la Toscana, e da lì la Sardegna, saltando chissà come il Lazio misterioso, almeno per me, che imparavo la geografia sulla mappa 1:1.000.000, ogni puntino un cliente, ogni cliente una storia, ogni manciata di storie un albergo, ogni albergo una saponettina profumata per la mia collezione.
Racchiusi in una scatola di latta profumata di pulito, in fondo all'armadio, anni di viaggi in macchina, partenza il lunedì e ritorno il venerdì, in mezzo le telefonate della sera, «passami Simone», «ciao babbo, dove sei?», e lui a raccontare, come il commesso viaggiatore di Favole al telefono, telegrafici dispacci, andando a ripescare i piccoli particolari capaci di stamparsi nella testa di un bambino, tra trattori giganti e campi immensi, clienti dai nomi buffi e paesi ancora più buffi, «babbo mi racconti ancora di Bitonto?», il bacio della buonanotte che dalla cornetta suonava sempre strano, «Bitont' Bitett' Bitritt' Toritto», poi gli ripassavo la mamma e lei chiudeva la porta e chissà che si dicevano.
All'epoca abitavamo in questa grande casa bianca, una villa circondata da un lungo giardino in discesa (o il salita, dipendeva dove stavi quando giocavi a pallone). Il giardino dava sulla strada che girava attorno al paese, giusto accanto a un bosco in miniatura, fitto fitto, che se ci andavi dentro ti sembrava sera pure a mezzogiorno. Tutto il resto erano campi. Grano, girasoli, barbabietole da zucchero.
E le sere d'estate ce ne stavamo io, mia mamma e mia nonna seduti davanti casa a chiacchierare e giocare a carte finché il sole calava. Chi voleva si portava un libro. Più spesso si parlava soltanto. Un'estate imparammo tutti insieme a giocare a scacchi, mentre nel campo lì vicino s'iniziava a lavorare, le sagome delle donne stagliate contro il crepuscolo sul crinale della collina, il trattore rosso che accendeva le luci e andava avanti tutta la notte, tagliando lentamente il panorama, illuminando coi fari il nero del boschetto, più denso di quello del cielo, col rumore dei cingoli che sembrava intonare un rumoroso inno quotidiano alla terra e al giorno che se ne andava, in coro con l'affannoso freno a motore dei camion che da giugno a settembre scendevano verso valle dalle campagne tutt'attorno, carichi di barbabietole dirette verso lo zuccherificio, in una lunga processione ansimante a scandire come un orologio le ore afose dell'estate di Monsano.
A un certo punto — non ricordo esattamente quando — mi comprarono una torcia. Potentissima. Un fascio di luce che dal centro del nostro giardino arrivava a disegnare cerchi sulle pareti scure del boschetto. Introdotta la variante, tra velleità da piccolo esploratore, i dopocena estivi diventarono coraggiose spedizioni al di là del vialetto per le auto, verso il grande orto — in discesa pure quello — già allora in stato di semiabbandono dopo la morte di mio nonno, simbolo di una dinastia di industriali in decadenza (dinastia che non avrebbe superato indenne gli anni Novanta — in quanto a conto in banca e proprietà — e infatti eccomi qua a scrivere invece di approvare piani di sviluppo o firmare assegni postdatati o appendermi al ramo dell'abete più alto del mio orto per non esser costretto a subire sulla pelle l'onta del dover mandare a casa i dipendenti).
Settanta operai, poi cinquanta, trenta, quindici, SpA, Srl, cambi di nome, ipoteche e firme. Settore macchine agricola, una vita con la terra e sulla terra. Overground. Tra frangizolle, erpici, aratri. Cataloghi con contadini sorridenti davanti a strani attrezzi verdi illuminati dal sole cocente. Cappellini da regalare ai figli dei clienti. Penne. Bloc-notes. Righelli. Il logo ovunque — Fabbrica Italiana Macchine Agricole — sempre più pesante da portare, anno dopo anno, coi puntini sulla mappa che si diradavano, la gente del paese che iniziava a chiacchierare sottovoce, gli sguardi e i sorrisetti. E intanto il nostro orto si riempiva di erbacce e puzzava di fermentazione, un tappeto di mele e fichi e pesche e ciliegie morbide da calpestare, il fascio bianco della torcia a inseguire Nerina, la gatta di casa, giù per quell'intricato labirinto di tronchi e canne e gabbiotti arrugginiti che un tempo ospitavano conigli belli grassi e polli, piccioni d'allevamento e tacchini, e gli ormai non più gloriosi resti di piante seminate da un bisnonno finito poi in ospedale — nel reparto dei matti — accanto a tentativi abortiti di salvare il salvabile, con pomodori striminziti che con energica costanza, estate dopo estate, crescevano di nuovo, più malridotti di quella precedente, quasi a non volersi arrendere all'inevitabile.
Laggiù, in mezzo all'odore di resina dei pini, la colonna sonora di grilli e cicale, i ronzii, i ticchettii dei rami, i fruscii dell'erba altra, l'orto che sembrava non finire mai e andava a intrecciarsi con gli ultimi rami nodosi del bosco lì accanto, Nerina sull'attenti, le orecchie dritte e la coda bassa, spaventata dai passi dei contadini al lavoro e dal trattore che lentamente saliva e scendeva, saliva e scendeva su quel mare di terra fertile. Poi, in fondo, un luminoso e pulsante tappeto volante di lucciole e io che provavo a prenderne una, dopo aver spento la torcia e aspettato che gli occhi si abituassero al buio giallo e azzurro illuminato dalla luna. E quando ci riuscivo tenevo quella lucina impalpabile tra le mani, sbirciando di tanto in tanto per vedere i palmi e le dita accendersi e spegnersi, cercando di non inciampare, cercando di evitare i rami rotti e le ortiche e le buche nascoste tra le erbacce.
Quando tornavo da mia madre e da mia nonna aprivo le mani e dentro c'era rimasto solo un insettino moribondo dall'addome chiaro che pulsava flebile finché poi più niente, l'ennesimo cadavere invisibile da buttare oltre la siepe, insieme ai noccioli di pesche e albicocche mangiate al pomeriggio sotto al sole.
«Vedrai che là crescerà un bell'albero». Ma non crebbe mai.
Quando mio padre arrivava lo vedevamo dal cancello automatico, la luce arancione che lampeggiava a intermittenza mentre i fanali della macchina proiettavano sul muro di casa le sagome delle capigliature anni Ottanta delle nostre teste. Quello coi capelli a spazzola ero io, quella con la permanente e la silhouette vagamente a forma di carciofo mia nonna, il frangettone e la cotonatura erano di mia madre. Allora ci precipitavamo già per le scale verso il porticato, aspettavamo che mio padre parcheggiasse, che la lucetta dall'interno si accendesse sul suo naso a punta e poi ci precipitavamo a turno incontro a lui. L'abbraccio del venerdì e la barba che pungeva. La giacca stesa sul sedile posteriore. La cravatta allentata. L'odore di stanchezza e di sedili. La ventola del motore. Le gomme sporche. Il baule che si apriva e la valigia rossa che sembrava pesantissima pure lì da ferma. Accanto, almeno un paio di cassette in legno piene di pesche o albicocche o melanzane. Bottiglie di vino. Barattoli sott'olio. Alici. Olive. Peperoncini. Pomodori. Il profumo caldo e zuccheroso della nostra dose settimanale di un'estate ben più esotica e rigogliosa di quella che vedevamo dietro alle alte siepi verdeazzurre del nostro giardino. Pezzetti di terre lontane ed estati altrui che arrivavano dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia, da paesi dai nomi strani come Casapesenna o Boscotrecase, dagli orti, dai campi e dagli allevamenti di clienti dagli accenti musicali, volti sconosciuti e nomi familiari, nascosti sotto ai puntini magnetici sulla mappa nell'ufficio di mio padre.
Il clack della valigia, in casa. Le scarpe nel sacchetto di panno, i vestiti da lavare, le cravatte arrotolate, la valigetta in pelle del beauty case. Altro clack. Altra saponetta in miniatura per la mia collezione. Lux, Palmolive, Mira Lanza, Davidoff. Quelche volta una scatoletta che spuntava. Un modellino di trattore. Le gomme morbide. Il rosso opaco di quelli Fiat o quello acceso dei Massey Ferguson. Il verde dei John Deere. Le lenzuola del lettone che diventavano campi immensi, sotto l'abat-jour, finché non era ora di andare a letto.
Il sabato mattina, quando tornavo a scuola, raccontavo di mozzarelle enormi che si scioglievano in bocca, di frutti più dolci di una caramella, di pesciolini minuscoli e quasi trasparenti, due puntini neri come occhi, ammucchiati in vasetti che non volevano mai aprirsi, di collane di pomodorini di un rosso che se lo guardavi troppo a lungo ti pareva di cascarci dentro. E loro mica ci credevano. E non credevano neppure agli spaghetti che stavano dritti sulla forchetta quando mia madre li tirava su un minuti prima di scolarli. La vedevi andare in ansia davanti al pentolone ancor prima di buttare la pasta, quando mio padre la chiamava da qualche area di servizio o la mattina dall'hotel: «Stasera arrivo con Coppola». E nelle sere come quella, in giardino ad aspettare ci stavo solo io. La nonna a casa sua e mia madre in cucina a preparare. Il tempo di una storia di Topolino e poi il cancello che lampeggiava un po' più a lungo, due Lancia Thema una dopo l'altra lungo la discesa a illuminare i miei capelli a spazzola. Due sportelli. Due valigie. Doppi passi sulle scale. La voce acuta di Coppola — un ometto che era poco più della metà di mio padre — i Ray-Ban da aviatore nel taschino della giacca, la camicia un poco aperta, due bottoni appena, in mano il primo telefono portatile mai visto in vita mia, dal peso e dalle dimensioni di un mattone, «Simo'! Ti sei fatto grande!», con l'accento sbagliato, la cadenza napoletana, mio padre che lo chiamava sempre e solo Raggionie', ché lui ci teneva e lo mandava sempre avanti quel titolo di ragioniere, prima di Giovanni — detto Gianni o anche Giovannino — e prima di Coppola, che era come lo chiamavano tutti gli altri, pure sue moglie qualche volta.
Coppola era il miglior amico di mio padre. Spesso viaggiavano insieme. Pure lui logato Fabbrica Italiana Macchine Agricole, già da prima di mio padre. Aveva iniziato con mio nonno e una sera di dieci anni prima — raccontava sempre — tutti e due erano pure rimasti senza portafogli e con una pistola puntata in faccia durante una rapina.
«Simo' li vuoi assaggiare 'sti pommodori? Per te li ho portati». E tirava fuori da una busta quei grossi grappoli che arrivavano dal Vesuvio, dal vulcano, rossi come il fuoco, gonfi di sole. «L'hai mai vista la pietra del Vesuvio?» chiedeva sempre, prima di andare a baciare mia madre, Paoletta, come la chiamava lui. E intanto io andavo a prendere quel pezzo di pietra lavica color melanzana che tenevo in camera e che Coppola aveva già visto mille volte. E iniziava il rito: lui a raccontare dei piennoli, mio padre ad accendere la pipa, in giardino, io ad ascoltare attento, mia madre che a un certo punto, dalla cucina, chiamava Coppola per l'assaggio e lui tirava fuori una forchetta d'argento dalla giacca, la sciacquava sotto l'acqua, la infilava nella pentola bollente, con noi tutt'attorno ad assistere alla Cerimonia degli Spaghetti al Denti. Ne tirava fuori uno. Lo guardava serio. L'elasticità. Il colore. Lo prendeva tra pollice e indice. Non un fiato. Alzava la testa e se lo infilava in bocca. Non un fiato, ancora. Masticava lento, assorto. «Manca un minuto. Poi puoi scolare, Paoletta».
E la serata riprendeva. In tavola il piatto di spaghetti al pomodoro più buoni mai assaggiati in vita mia. Il tintinnio dei bicchieri, il metallo delle forchette sulle ceramiche, le bocche piene e il suono lucido e gonfio della pasta e dei pomodorini mentre li infilavi in bocca, senza sapere che il tempo delle lucciole, del cancello automatico, di Nerina la gatta, dei camion di barbabietole, dei trattori, dei papaveri che spuntavano in mezzo ai campi, dei puntini magnetici e delle saponettine degli alberghi non sarebbe durato ancora a lungo.
Oggi in quella cosa abita abita qualcun altro, l'azienda di famiglia non c'è più, di penne marchiate Fabbrica Italiana Macchine Agricole ne sono rimaste poche e senza inchiostro, Coppola è una foto da tenere nel portafogli, 1947–2011, di pomodorini del piennolo non se ne vedono più e l'Era degli Spaghetti al Dente è finita da un pezzo. Ma il sapore, quello me lo ricordo ancora bene.