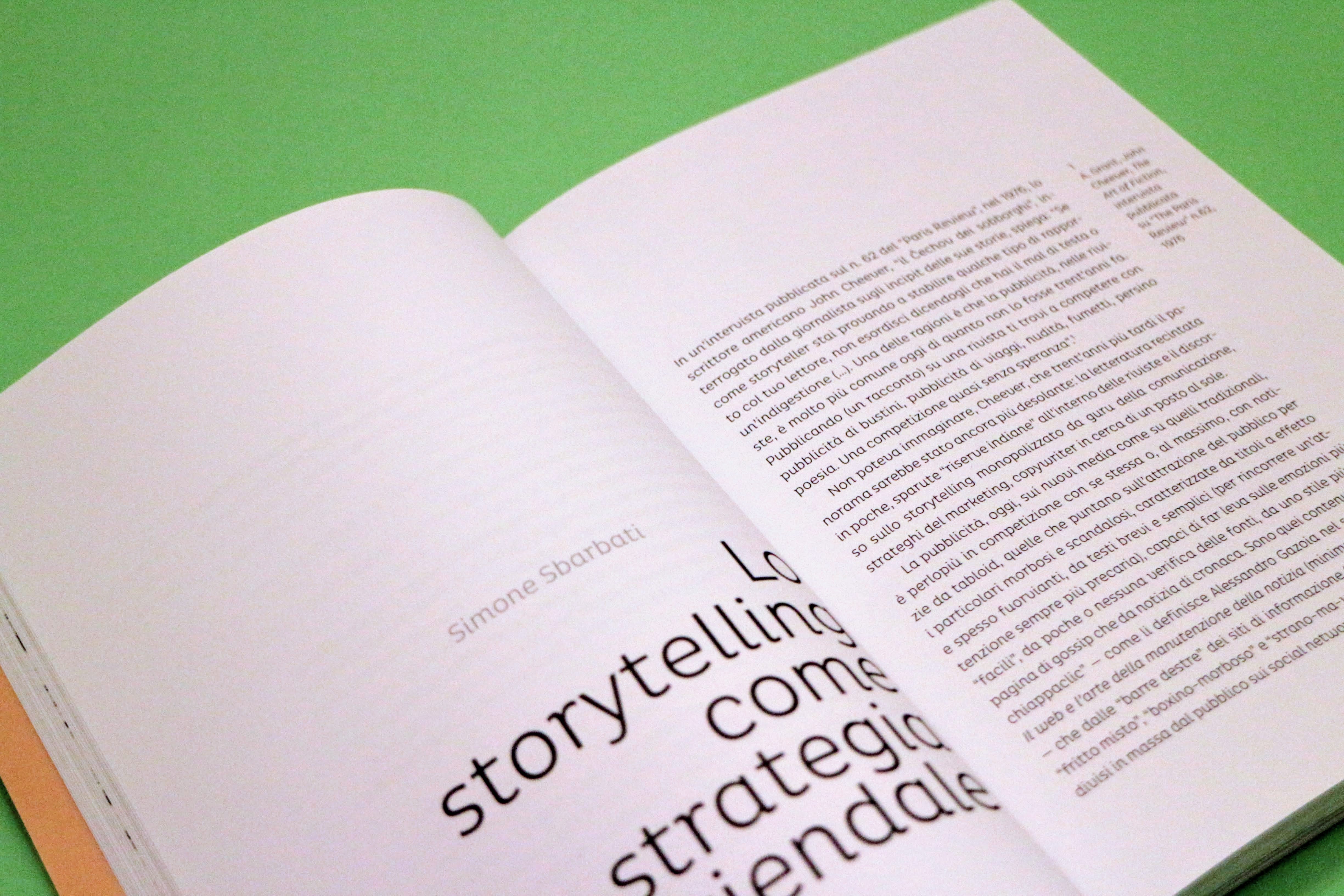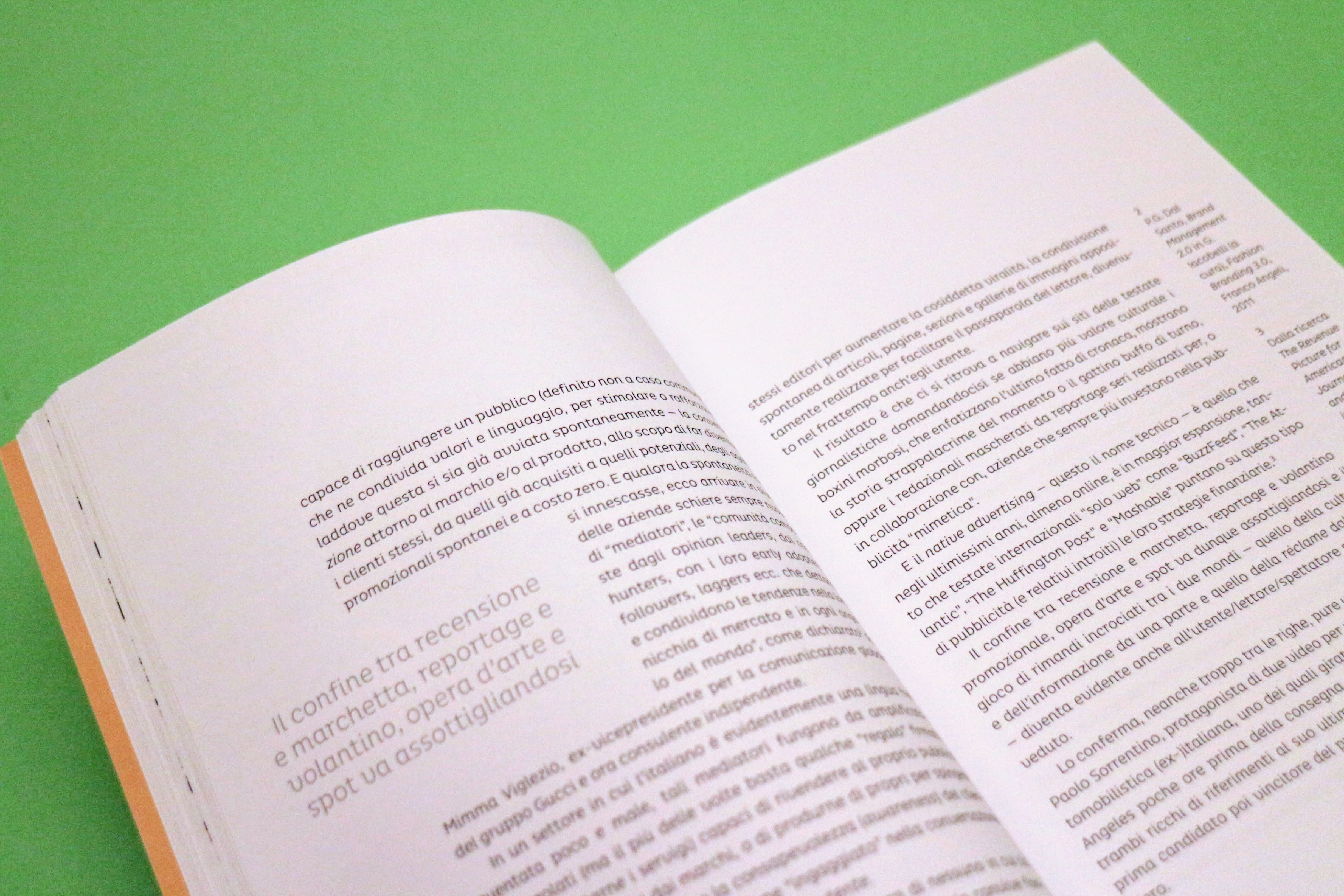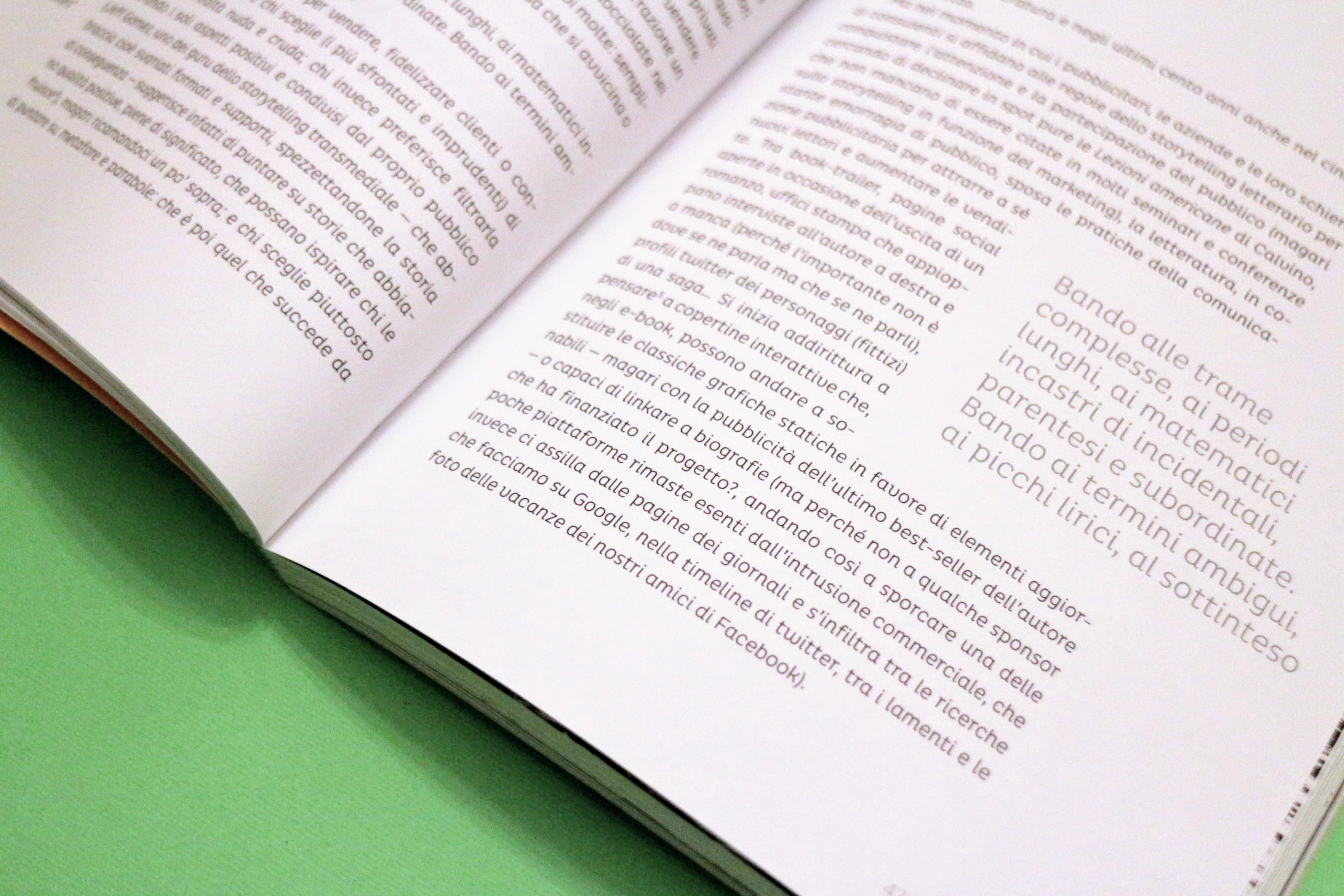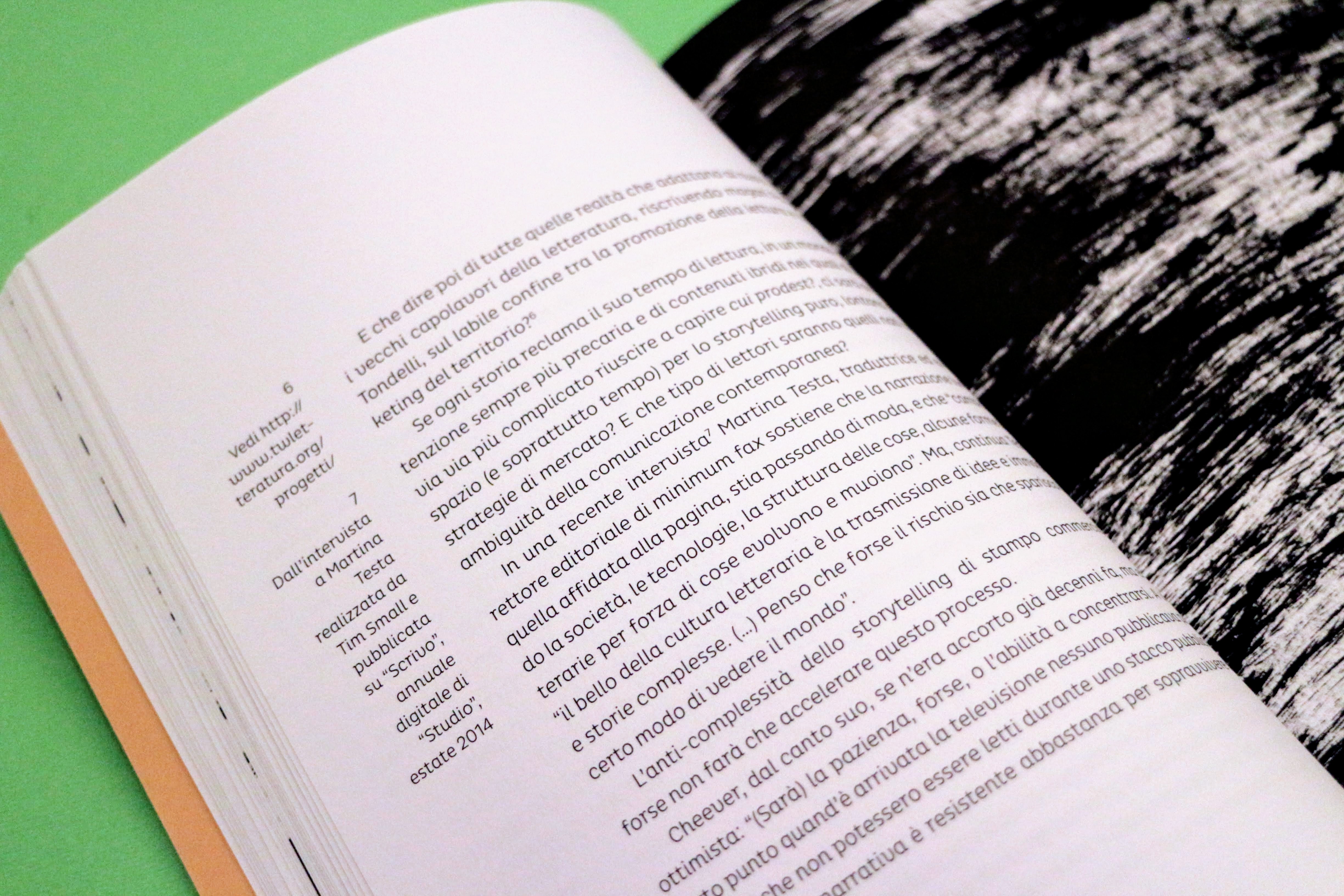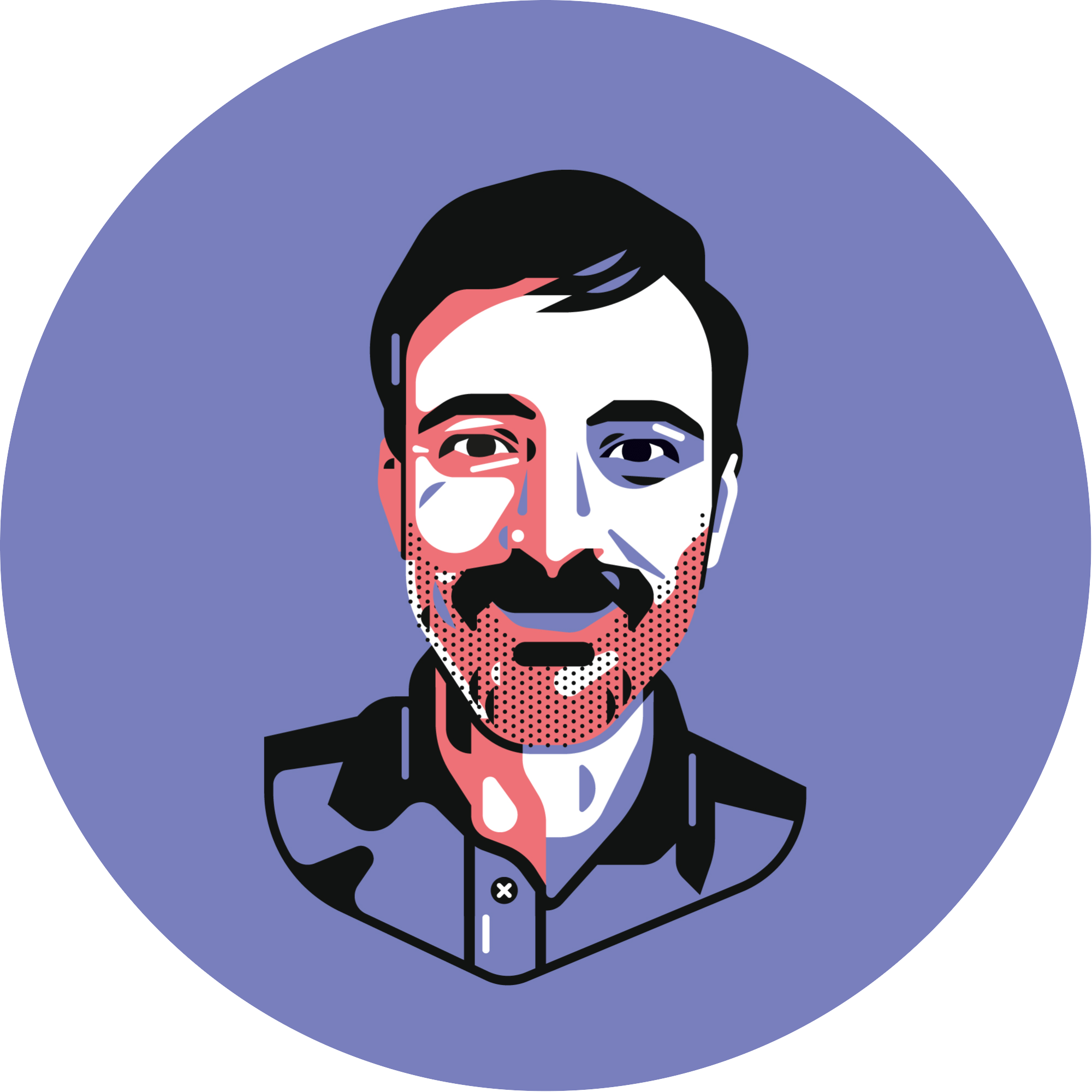Hamelin nº37.
Troppe storie
settembre, 2014
Hamelin è una rivista di cultura pubblicata dall'omonima associazione culturale che ha sede a Bologna (è la stessa che organizza anche il festival internazionale del fumetto BilBOlbul).
Questo numero è dedicato alle storie e mi hanno chiesto un saggio critico sul cosiddetto “storytelling”.
a cura di • Hamelin Associazione Culturale
illustrazione di copertina • Laurent Moreau
illustrazione interne • Serena Schinaia
progetto grafico e impaginazione • Roberta Contarini
Lo storytelling come strategia aziendale
In un’intervista pubblicata sul n. 62 del Paris Review, nel 1976, lo scrittore americano John Cheever, “il Čechov dei sobborghi”, interrogato dalla giornalista sugli incipit delle sue storie, spiega: «Se come storyteller stai provando a stabilire qualche tipo di rapporto col tuo lettore, non esordisci dicendogli che hai il mal di testa o un’indigestione […]. Una delle ragioni è che la pubblicità, nelle riviste, è molto più comune oggi di quanto non lo fosse trent’anni fa. Pubblicando [un racconto] su una rivista ti trovi a competere con pubblicità di bustini, pubblicità di viaggi, nudità, fumetti, persino poesia. Una competizione quasi senza speranza»1.
Non poteva immaginare, Cheever, che trent’anni più tardi il panorama sarebbe stato ancora più desolante: la letteratura recintata in poche, sparute “riserve indiane” all’interno delle riviste e il discorso sullo storytelling monopolizzato da guru della comunicazione, strateghi del marketing, copywriter in cerca di un posto al sole.
La pubblicità, oggi, sui nuovi media come su quelli tradizionali, è perlopiù in competizione con sé stessa o, al massimo, con notizie da tabloid, quelle che puntano sull’attrazione del pubblico per i particolari morbosi e scandalosi, caratterizzate da titoli a effetto e spesso fuorvianti, da testi brevi e semplici (per rincorrere un’attenzione sempre più precaria), capaci di far leva sulle emozioni più “facili”, da poche o nessuna verifica delle fonti, da uno stile più da pagina di gossip che da notizia di cronaca. Sono quei contenuti “acchiappaclic” — come li definisce Alessandro Gazoia nel suo saggio Il web e l’arte della manutenzione della notizia (Minimum Fax, 2013) — che dalle “barre destre” dei siti di informazione (chiamati anche “fritto misto”, “boxino-morboso” e “strano-ma-vero”) vengono condivisi in massa dal pubblico sui social network, spesso nell’ordine di migliaia di volte in più rispetto agli approfondimenti, agli editoriali, alle storie nel senso più alto del termine.
Quello stesso pubblico, assalito com’è da contenuti “notiziabili” di ogni tipo, si trova a dover dividere la propria precaria attenzione (e, con sempre maggior difficoltà, discernere) tra notizie vere e pseudonotizie, tra i fatti privati della propria cerchia di amici su Facebook e contenuti pubblicitari che sempre più cercano di “mimetizzarsi” in mezzo al flusso di informazioni, non più attraverso escamotage grafici (come nel caso dei pubbliredazionali) ma piazzando il proprio messaggio promozionale — più o meno esplicito e aggressivo — attraverso formati di comunicazione fino a qualche anno fa generalmente liberi dall’influenza delle aziende, andando a conquistare un territorio culturale che sempre più è diventato territorio “grigio”, senza barriere, sfruttando il ruolo di inconsapevole ariete che l’arte, con la sua sperimentazione sui linguaggi, ha avuto nell’abbattere — in buona fede — ogni steccato.
Il discorso attorno alle strategie di marketing e comunicazione, negli ultimi decenni rimasto solitamente confinato nelle aule universitarie, negli open space delle agenzie specializzate e tra le pagine dei saggi per addetti ai lavori, ora viaggia rapido in rete aperto ai contributi di esperti o presunti tali (anche in questo caso discernere è attività che si presta a molteplici errori di valutazione): pagine web dedicate unicamente a discutere (nei casi migliori) o dare facili ricette (in quelli peggiori) nascono a ritmo forsennato, i social network si riempiono di personaggi che si auto-etichettano come “digital strategist”, “new media marketing expert” e altre svariate, rigorosamente anglofone, variazioni sul tema. Tra le parole chiave citate da tali strateghi, quelle che compaiono più di frequente hanno a che fare con la creazione di una narrazione (storytelling) capace di raggiungere un pubblico (definito non a caso community) che ne condivida valori e linguaggio, per stimolare o rafforzare — laddove questa si sia già avviata spontaneamente — la conversazione attorno al marchio e/o al prodotto, allo scopo di far diventare i clienti stessi, da quelli gia acquisiti a quelli potenziali, degli agenti promozionali spontanei e a costo zero. E qualora la spontaneità non si innescasse, ecco arrivare in aiuto delle aziende schiere sempre nuove di “mediatori”, le «comunità composte dagli opinion leaders, dai cool hunters, con i loro early adopters, followers, laggers ecc. che dettano e condividono le tendenze nella loro nicchia di mercato e in ogni angolo del mondo», come dichiarato2 da Mimma Viglezio, ex-vicepresidente per la comunicazione globale del gruppo Gucci e ora consulente indipendente.
In un settore in cui l’italiano è evidentemente una lingua frequentata poco e male, tali mediatori fungono da amplificatori prezzolati (ma il più delle volte basta qualche “regalo” firmato per conquistarne i servigi) capaci di rivendere al proprio pubblico contenuti prodotti dai marchi, o di produrne di propri per spingere all’acquisto o aumentare la consapevolezza (awareness) del cliente, che nel momento in cui viene “ingaggiato” nella conversazione diventa un più burocratico e freddo utente.
A conferma dell’esistenza di questa terra di nessuno in cui ciò che viene creato unicamente a scopo commerciale convive fianco a fianco e senza soluzione di continuità con l’informazione pura, c’è da notare come le medesime strategie vengano applicate dagli stessi editori per aumentare la cosiddetta viralità, la condivisione spontanea di articoli, pagine, sezioni e gallerie di immagini appositamente realizzate per facilitare il passaparola del lettore, divenuto nel frattempo anch’egli utente.
Il risultato è che ci si ritrova a navigare sui siti delle testate giornalistiche domandandocisi se abbiano più valore culturale i boxini morbosi, che enfatizzano l’ultimo fatto di cronaca, mostrano la storia strappalacrime del momento o il gattino buffo di turno, oppure i redazionali mascherati da reportage serî realizzati per, o in collaborazione con, aziende che sempre più investono nella pubblicità “mimetica”.
E il native advertising — questo il nome tecnico — è quello che negli ultimissimi anni, almeno online, è in maggior espansione, tanto che testate internazionali “solo web” come BuzzFeed, The Atlantic, The Huffington Post e Mashable puntano su questo tipo di pubblicità (e relativi introiti) le loro strategie finanziarie3.
Il confine tra recensione e marchetta, reportage e volantino promozionale, opera d’arte e spot va dunque assottigliandosi e il gioco di rimandi incrociati tra i due mondi — quello della cultura e dell’informazione da una parte e quello della réclame dall’altra — diventa evidente anche all’utente/lettore/spettatore meno avveduto.
Lo conferma, neanche troppo tra le righe, pure un regista come Paolo Sorrentino, protagonista di due video per una nota casa automobilistica (ex-)italiana, uno dei quali girato per le strade di Los Angeles poche ore prima della consegna dei premi Oscar ed entrambi ricchi di riferimenti al suo ultimo film, La grande bellezza, prima candidato poi vincitore del premio come miglior film straniero.
Nell’era dei nuovi media l’imperativo, per un’azienda, è quindi quello di raccontare storie. Prova ne sono convegni, corsi universitari, workshop e lectio magistralis: basta uno storytelling nel titolo per riempire le aule di manager, imprenditori, aspiranti strateghi e futuri consulenti. E chi scrive confessa, non senza una punta di amarezza, di frequentare spesso quella zona grigia dove l’informazione, il racconto e il marketing convivono (i primi due in funzione di quest’ultimo), utilizzando le storie per “rivendere” ai propri lettori prodotti, eventi, progetti e idee e basando le proprie lezioni, in qualità di docente in una pubblica università come pure di corsi privati e consulenze, sul raccontare in funzione del promuovere e vendere.
Ma quali sono gli “ingredienti” che fanno di una narrazione un mezzo efficace per un’azienda? Le parole chiave snocciolate nei simposi e raccolte in studiatissime slide non sono poi molte: semplicità, brevità, emozione, condivisibilità e (qualcosa che si avvicina o possa essere percepito come) sincerità.
Bando alle trame complesse, ai periodi lunghi, ai matematici incastri di incidentali, parentesi e subordinate. Bando ai termini ambigui, ai picchi lirici, al sottinteso.
Tra chi racconta storie per vendere, fidelizzare clienti o conquistarne di nuovi c’è chi sceglie (i più sfrontati e imprudenti) di mostrare la realtà nuda e cruda; chi invece preferisce filtrarla mostrando i soli aspetti positivi e condivisi dal proprio pubblico (Jeff Gomez, uno dei guru dello storytelling transmediale — che abbraccia cioè svariati formati e supporti, spezzettandone la storia di conseguenza — suggerisce infatti di puntare su storie che abbiano qualità positive, piene di significato, che possano ispirare chi le fruisce4), magari ricamandoci un po’ sopra; e chi sceglie piuttosto di puntare su metafore e parabole: che è poi quel che succede da secoli nella letteratura e negli ultimi cento anni anche nel cinema e nel fumetto.
Ma nel momento in cui i pubblicitari, le aziende e le loro schiere di consulenti si affidano alle regole dello storytelling letterario per conquistare l’attenzione e la partecipazione del pubblico (magari cercando di declinare in spot pure le Lezioni americane di Calvino, che non mancano di essere citate in molti seminari e conferenze sullo storytelling in funzione del marketing), la letteratura, in costante emorragia di pubblico, sposa le pratiche della comunicazione pubblicitaria per attrarre a sé nuovi lettori e aumentare le vendite. Tra book-trailer, pagine social aperte in occasione dell’uscita di un romanzo, uffici stampa che appioppano interviste all’autore a destra e a manca (perché l’importante non è dove se ne parla ma che se ne parli), profili twitter dei personaggi (fittizi) di una saga… Si inizia addirittura a pensare5 a copertine interattive che, negli e-book, possono andare a sostituire le classiche grafiche statiche in favore di elementi aggiornabili — magari con la pubblicità dell’ultimo best-seller dell’autore — o capaci di linkare a biografie (ma perché non a qualche sponsor che ha finanziato il progetto?, andando così a sporcare una delle poche piattaforme rimaste esenti dall’intrusione commerciale, che invece ci assilla dalle pagine dei giornali e s’infiltra tra le ricerche che facciamo su Google, nella timeline di twitter, tra i lamenti e le foto delle vacanze dei nostri amici di Facebook).
E che dire poi di tutte quelle realtà che adattano ai nuovi media i vecchi capolavori della letteratura, riscrivendo magari Pavese o Tondelli, sul labile confine tra la promozione della lettura e il marketing del territorio6?
Se ogni storia reclama il suo tempo di lettura, in un mondo di attenzione sempre più precaria e di contenuti ibridi nei quali diventa via via più complicato riuscire a capire cui prodest?, ci sarà ancora spazio (e soprattutto tempo) per lo storytelling puro, lontano dalle strategie di mercato? E che tipo di lettori saranno quelli nati tra le ambiguità della comunicazione contemporanea?
In una recente intervista Martina Testa7, traduttrice ed ex-direttore editoriale di minimum fax sostiene che la narrazione lunga, quella affidata alla pagina, stia passando di moda, e che «cambiando la società, le tecnologie, la struttura delle cose, alcune forme letterarie per forza di cose evolvono e muoiono». Ma, continua Testa, «il bello della cultura letteraria è la trasmissione di idee e immagini e storie complesse. […] Penso che forse il rischio sia che sparisca un certo modo di vedere il mondo».
L’anti-complessità dello storytelling di stampo commerciale forse non farà che accelerare questo processo.
Cheever, dal canto suo, se n’era accorto già decenni fa, ma era ottimista: «[Sarà] la pazienza, forse, o l’abilità a concentrarsi. A un certo punto quand’è arrivata la televisione nessuno pubblicava più articoli che non potessero essere letti durante uno stacco pubblicitario. Ma la narrativa è resistente abbastanza per sopravvivere a tutto questo»8.
Note:
- Da John Cheever, The Art of Fiction, intervista di Annette Grant, pubblicata su The Paris Review n.67, autunno 1976.
- Da Brand Management 2.0, di Pier Giorgio Dal Santo, raccolto in Fashion Branding 3.0, a cura di Giuseppe Iacobelli, Franco Angeli 2011.
- Da Brand Management 2.0, di Pier Giorgio Dal Santo, raccolto in Fashion Branding 3.0, a cura di Giuseppe Iacobelli, Franco Angeli 2011.
- Dalla ricerca The revenue picture for american journalism and how it is changing pubblicata nel marzo del 2014 (http://www.journalism.org/2014/03/26/a-deeper-look-at-the-digital-advertising-landscape/).
- Dall’intervista a Jeff Gomez realizzata da Paula Bernstein e pubblicata dal sito Indiewire nel dicembre del 2013 (http://www.indiewire.com/article/the–3-rules-of-transmedia-storytelling-from-transmedia-guru-jeff-gomez).
- Da Chi ha detto che le copertine scompariranno?, di Stefania Parmeggiani, pubblicato su La Repubblica del 13 agosto 2014 nell’inserto R2 Cultura.
- Vedi http://www.twletteratura.org/progetti/
- Dall’intervista a Martina Testa realizzata da Tim Small e pubblicata su Scrivo, annuale digitale di Studio sui libri e quello che diventeranno, estate 2014.
- Da John Cheever, The Art of Fiction, intervista di Annette Grant, pubblicata su The Paris Review n.67, autunno 1976.