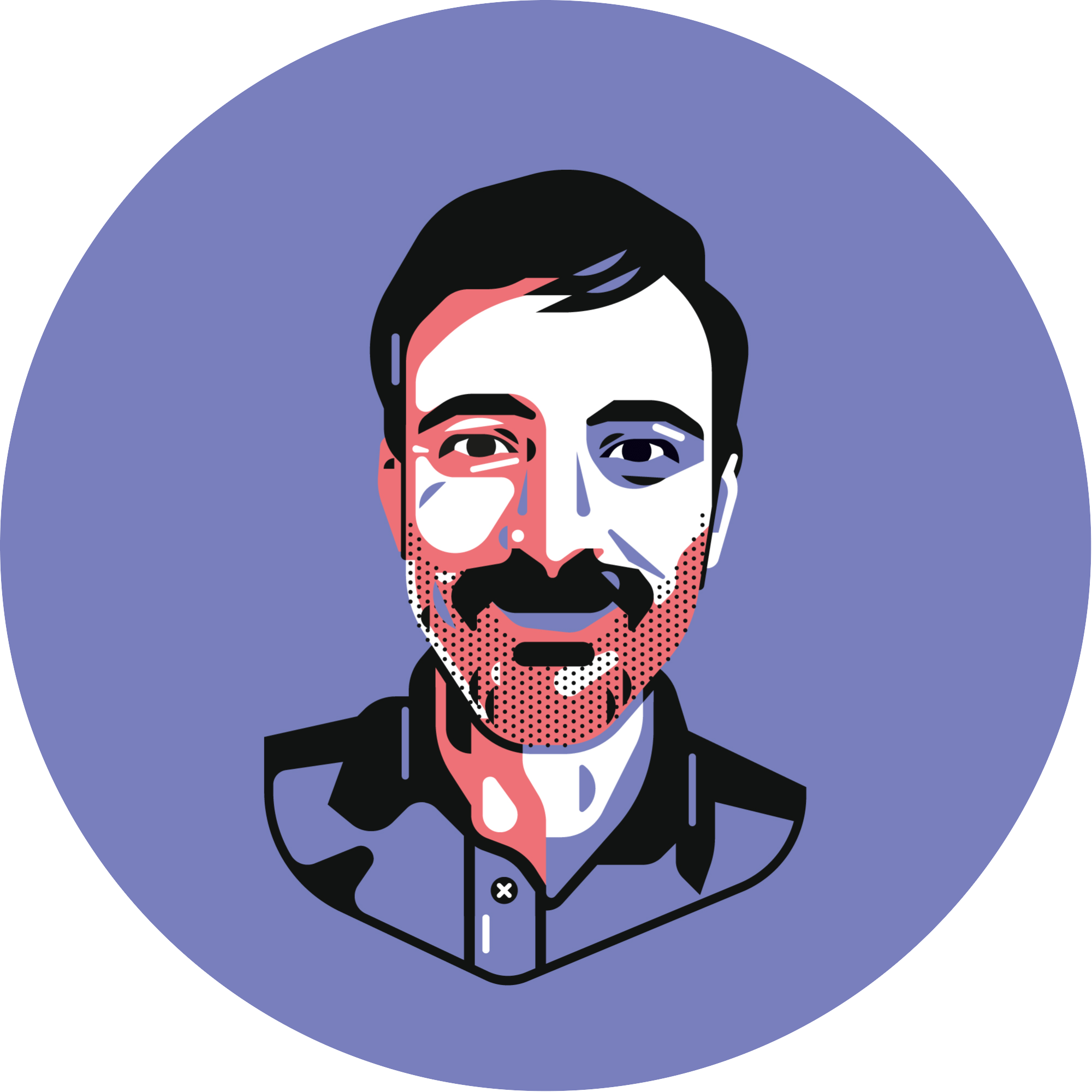Il mercato sono storie
Dispensa, 2014
Un piccolo reportage dal Mercato delle Erbe di Jesi, realizzato seguendo mia nonna che faceva la spesa.
È stato pubblicato sul sito della rivista Dispensa.
testo e foto • Simone Sbarbati
Al banco del pesce le cozze sono finite. Anzi, più precisamente sono i móscioli ad esser finiti. Così, nella zona di Ancona, chiamiamo le piccole e gustosissime cozze selvagge che tradizionalmente vengono pescate in apnea alle pendici del Conero, il monte che i greci battezzarono komaros (corbezzolo), per via dell’arbusto, molto diffuso da queste parti; monte (in realtà appena 500 metri ma visto dal mare appare imponente) che dà anche il nome ad un magnifico vino rosso.
Il pescivendolo, con l’aria di chi l’ha già ripetuto mille volte, dice che bisogna arrivare presto, ché i móscioli finiscono subito e già alle 8,00 del mattino quelli che arrivano presto si portano via tutto. Ci lascia il suo numero di telefono. Quattro cifre, che si ripetono due a due, più il prefisso.
«È più semplice di quello della questura», dice ridendo, «mi chiami martedì mattina che gliele tengo da parte».
Sono le nove e mezzo e al Mercato Pubblico di Jesi, 25km nell’entroterra di Ancona, patria del Verdicchio, 23 medaglie olimpiche in bacheca grazie alla scherma —gloriosa tradizione locale fin dagli anni ’50 — oltre che città natale di Federico II di Svevia, lo stupor mundi che ringrazio pure per aver ispirato il nome di mia figlia (Sveva); al Mercato Pubblico, dicevo, c'è un piccolo ma costante viavai di persone.
Un sole d’inizio agosto, fuori, batte incandescente sui tettucci delle auto che passano e ripassano in cerca dell’ultimo parcheggio rimasto, arrischiandosi di tanto in tanto in doppie file subito punite con contravvenzioni che scatenano litanie di scuse, con gli arroganti automobilisti viziati dagli enormi parcheggi dei centri commerciali e contagiati dalla distorta forma mentis degli amministratori che da anni cercano di adattare una struttura urbanistica concepita per essere vissuta in verticale, su due piedi, alla pigrizia degli autodipendenti, perennemente seduti, costantemente nervosi, pronti ad accampare i soliti cinque minuti cinque, non di più, giusto il tempo per...
Mentre i clacson strombettano, i vigili urbani minacciano, qualche imbranato inchioda davanti all'attempata signora che riconquista il suo diritto ad attraversare con orgogliosa lentezza sulle strisce, e tutti sudano più del dovuto, lucidi dietro i loro occhiali da sole, nella penombra del Mercato si gira tra i banchi di frutta e verdura, tra i salumi e i formaggi, i tranci di carne, i baccalà sotto sale e gli stoccafissi appesi, ciascuno godendosi la frescura di quelle vecchie ed imponenti mura dove, da 150 anni, i cittadini di Jesi e dei castelli della valle dell’Esino comprano e vendono generi alimentari.
Progettato nel 1859 dall’allora architetto comunale Ciriaco Santini nell’ambito di una serie di opere pubbliche pensate per una cittadina in via di espansione qual era Jesi, il Mercato Pubblico fu pensato soprattutto per «gli artieri ed i poveri, perché con generoso provvedimento fornisce lavoro a chi abbisogna di pane», così fece scrivere l’architetto nella sua dedica al Gonfaloniere che aveva voluto la costruzione di quell’opera pubblica, inizialmente battezzata Beccheria (così veniva chiamata l’attuale macelleria), Pescheria e Mattatoio. I lavori, che iniziarono seppellendo sotto alla prima pietra una cassetta contenente una medaglia di bronzo con su incisa la scritta S.P.Q.AE (il nome latino di Jesi era Aesis), terminarono nel 1862, appena un anno dopo l’Unità d’Italia.
Da allora la Beccheria, poi ribattezzata Mercato Pubblico ma oggi comunemente conosciuta come Mercato delle Erbe, ha attraversato la storia cittadina, passando per due guerre mondiali e numerosi interventi di restauro ma conservando sempre il medesimo ruolo, cosa rara, in un Paese dove le opere di “archeologia urbana” vengono spesso riqualificate ad altri uso ed altrettanto di frequente abbandonate all’incuria e al degrado.
Un buon terzo di quei 150 anni di storia mia nonna li ha vissuti direttamente ed è con quella vispa vecchina, che mi auguro abbia lasciato anche a me l’invidiabile corredo genetico che le ha permesso di avere lo spirito e le forze di arrampicarsi sugli alberi fin oltre i sessanta, che visito il Mercato di Jesi, dove tutti la conoscono, cliente fedele quanto rompiscatole da oltre cinquant’anni.
Da allora la Beccheria, poi ribattezzata Mercato Pubblico ma oggi comunemente conosciuta come Mercato delle Erbe, ha attraversato la storia cittadina, passando per due guerre mondiali e numerosi interventi di restauro ma conservando sempre il medesimo ruolo, cosa rara, in un Paese dove le opere di “archeologia urbana” vengono spesso riqualificate ad altri uso ed altrettanto di frequente abbandonate all’incuria e al degrado.
Un buon terzo di quei 150 anni di storia mia nonna li ha vissuti direttamente ed è con quella vispa vecchina, che mi auguro abbia lasciato anche a me l’invidiabile corredo genetico che le ha permesso di avere lo spirito e le forze di arrampicarsi sugli alberi fin oltre i sessanta, che visito il Mercato di Jesi, dove tutti la conoscono, cliente fedele quanto rompiscatole da oltre cinquant’anni.
«Quando c'era la guerra ero una bambina. A Montecarotto, dove vivevo, ci fu una grande battaglia. C'erano pure i paracadutisti. Io sentivo le canzoni degli americani. Non capivo quello che dicevano ma mi arrampicavo sul tetto di casa, scalza, e cantavo con loro. I vicini dicevano che con una voce come la mia dovevo andare a cantare alla radio».
Mio nonno lo conobbe che entrambi erano ancora ragazzini. Abitavano a pochi passi l’uno dall’altra e tutte le mattine percorrevano insieme la stessa strada per andare a lavorare: lei imparava a fare la sarta e lui, Dalmo, andava a bottega dal meccanico del paese. I primi amoreggiamenti in mezzo ai canneti, accanto ai fossi, confini naturali dei poderi, all’epoca popolati da strane apparizioni, dimora di dicerie e superstizioni rurali: «gli spiriti e le streghe c’erano. Lo sapevano tutti. Ora non esistono più» mi ha spiegato lei una volta, col suo solito mai del tutto ingenuo candore, dopo avermi raccontato la storia di una strana creatura nera con un grande cappello pure nero che apparve all’improvviso di fronte a mio nonno, che allora era ancora il suo fidanzato, proprio in mezzo ad un canneto, per poi sparire nel nulla quando lui corse verso casa a prendere il fucile. La magia andava di pari passo con la cultura contadina, con i riti pagani della campagna e — immagino io — con le erbe psicotrope assunte più o meno inconsapevolmente insieme a quelle più innocue, raccolte ai margini dei campi.
Mio nonno e mia nonna si sposarono qualche anno più tardi. Lei aveva 18 anni. Lui 20 ed era comunista, per questo il prete, all’inizio, non voleva sposarli.
Dal paesino si trasferirono a Jesi, dove mio nonno iniziò a lavorare con operaio in una fabbrica di macchine agricole mentre mia nonna, da casa, faceva la sarta conto terzi.
Mia madre nacque qualche anno dopo, dopo una sorella che non conobbe mai, Maria, morta quando aveva due anni, ed aborto spontaneo che però mia nonna tenne nascosto per decenni.
Nel frattempo Dalmo si era messo in proprio. Sempre macchine agricole. Un piccola officina lungo la statale che portava verso Roma. Iniziarono a girare i soldi, i clienti, le segretarie, le donne...
Mentre scendiamo a braccetto le scalette che portano al piano inferiore del mercato, nonna mi racconta che la prima segretaria di suo marito un giorno le disse, maliziosa, che l’indomani sarebbe andata con lui ad Ancona per lavoro.
«E tu?» chiedo io.
«Io l’ho presa per i capelli e l’ho riempita di botte. Le ho pure tirato un pezzo di legno che ho trovato lì per terra. Poi sono tornata a casa. Tremavo tutta. Sono finita a letto con la febbre al quaranta per i nervi».
Nel ’61 si separarono. E lei tirò su da sola mia madre, tra mille fatiche e completamente ignara di come allevare una figlia, che ad un certo punto venne pure messa in collegio. Nata tra i campi, immersa fino al collo nella cultura contadina d’inizio secolo, gli “studi” arrivati solo fino alla terza elementare, la voce da usignolo e la presenza da attrice del cinema muto, la fama di “bella del paese”, nelle vene l’egoistico spirito di conservazione dei poveracci, mia nonna non dev’essere stata una madre modello. E nei quotidiani battibecchi tra lei e la mia, di madre, si possono ancora trovare tracce inequivocabili dei lunghi anni durante i quali i ruoli, tra loro, erano invertiti: madre la figlia e figlia la madre.
Mio nonno lo conobbe che entrambi erano ancora ragazzini. Abitavano a pochi passi l’uno dall’altra e tutte le mattine percorrevano insieme la stessa strada per andare a lavorare: lei imparava a fare la sarta e lui, Dalmo, andava a bottega dal meccanico del paese. I primi amoreggiamenti in mezzo ai canneti, accanto ai fossi, confini naturali dei poderi, all’epoca popolati da strane apparizioni, dimora di dicerie e superstizioni rurali: «gli spiriti e le streghe c’erano. Lo sapevano tutti. Ora non esistono più» mi ha spiegato lei una volta, col suo solito mai del tutto ingenuo candore, dopo avermi raccontato la storia di una strana creatura nera con un grande cappello pure nero che apparve all’improvviso di fronte a mio nonno, che allora era ancora il suo fidanzato, proprio in mezzo ad un canneto, per poi sparire nel nulla quando lui corse verso casa a prendere il fucile. La magia andava di pari passo con la cultura contadina, con i riti pagani della campagna e — immagino io — con le erbe psicotrope assunte più o meno inconsapevolmente insieme a quelle più innocue, raccolte ai margini dei campi.
Mio nonno e mia nonna si sposarono qualche anno più tardi. Lei aveva 18 anni. Lui 20 ed era comunista, per questo il prete, all’inizio, non voleva sposarli.
Dal paesino si trasferirono a Jesi, dove mio nonno iniziò a lavorare con operaio in una fabbrica di macchine agricole mentre mia nonna, da casa, faceva la sarta conto terzi.
Mia madre nacque qualche anno dopo, dopo una sorella che non conobbe mai, Maria, morta quando aveva due anni, ed aborto spontaneo che però mia nonna tenne nascosto per decenni.
Nel frattempo Dalmo si era messo in proprio. Sempre macchine agricole. Un piccola officina lungo la statale che portava verso Roma. Iniziarono a girare i soldi, i clienti, le segretarie, le donne...
Mentre scendiamo a braccetto le scalette che portano al piano inferiore del mercato, nonna mi racconta che la prima segretaria di suo marito un giorno le disse, maliziosa, che l’indomani sarebbe andata con lui ad Ancona per lavoro.
«E tu?» chiedo io.
«Io l’ho presa per i capelli e l’ho riempita di botte. Le ho pure tirato un pezzo di legno che ho trovato lì per terra. Poi sono tornata a casa. Tremavo tutta. Sono finita a letto con la febbre al quaranta per i nervi».
Nel ’61 si separarono. E lei tirò su da sola mia madre, tra mille fatiche e completamente ignara di come allevare una figlia, che ad un certo punto venne pure messa in collegio. Nata tra i campi, immersa fino al collo nella cultura contadina d’inizio secolo, gli “studi” arrivati solo fino alla terza elementare, la voce da usignolo e la presenza da attrice del cinema muto, la fama di “bella del paese”, nelle vene l’egoistico spirito di conservazione dei poveracci, mia nonna non dev’essere stata una madre modello. E nei quotidiani battibecchi tra lei e la mia, di madre, si possono ancora trovare tracce inequivocabili dei lunghi anni durante i quali i ruoli, tra loro, erano invertiti: madre la figlia e figlia la madre.
Ma intanto ecco che i contadini del mercato la salutano raggianti: «Nenella!» urla un vecchio rattrappito appoggiato al bastone, seduto dietro casse di maragnà (melanzane), pommidori, persighi (pesche), peperù (peperoni), sèlleri (sedani)...
Lei contratta su tutto, chiede sconti, tasta, annusa, pretende assaggi. Altro che guantini sterili e sacchetti di plastica.
«Hai mai comprato frutta o verdura in un supermercato?» chiedo.
«Mai. Nemmeno una volta. Lì te lo fanno lo sconto?».
Giriamo per i banchi e lei mi presenta tutti, orgogliosa. Uno dei contadini fa battute su Berlusconi. Quasi le sussurra nell’orecchio di mia nonna, come fossero confidenze private. Sa come la pensa lei, ma non vuole rischiare di perdere clienti, immagino.
Al mercato girano soprattutto anziani. Vecchie signore piene di buste, come mia nonna.
Una delle storie di famiglia, di quelle che tiriamo fuori quando a pranzo ci sono estranei, cugini lontani, nuove fidanzate, e che servono più che altro per presentare — come una sorta di carta d’identità in forma di narrazione — i vari membri della famiglia, racconta di una volta in cui mia nonna tornò a casa completamente scalcinada, malmessa, sudata, con le ginocchia sbucciate e sanguinanti, le calze rotte, il vestito sporco. Era caduta su per il Montirozzo — così si chiama una parte delle mura medievali di Jesi — tornando proprio dal mercato. In mano due buste piene di roba. Intatte. Costretta a scegliere se salvare la spesa o le ginocchia, Nenella non aveva esitato a sacrificare la pelle. Perlomeno un pezzetto.
Ma non è l’unica.
«Ogni tanto c’è qualche signora che casca per le scale del mercato, quelle che portano dal piano di sopra a quello di sotto. Capita di vedere macchie di sangue mentre scendi» dice lei ridendo. E chissà se pure loro sacrificano un gomito o un ginocchio piuttosto che la spesa.
Lei contratta su tutto, chiede sconti, tasta, annusa, pretende assaggi. Altro che guantini sterili e sacchetti di plastica.
«Hai mai comprato frutta o verdura in un supermercato?» chiedo.
«Mai. Nemmeno una volta. Lì te lo fanno lo sconto?».
Giriamo per i banchi e lei mi presenta tutti, orgogliosa. Uno dei contadini fa battute su Berlusconi. Quasi le sussurra nell’orecchio di mia nonna, come fossero confidenze private. Sa come la pensa lei, ma non vuole rischiare di perdere clienti, immagino.
Al mercato girano soprattutto anziani. Vecchie signore piene di buste, come mia nonna.
Una delle storie di famiglia, di quelle che tiriamo fuori quando a pranzo ci sono estranei, cugini lontani, nuove fidanzate, e che servono più che altro per presentare — come una sorta di carta d’identità in forma di narrazione — i vari membri della famiglia, racconta di una volta in cui mia nonna tornò a casa completamente scalcinada, malmessa, sudata, con le ginocchia sbucciate e sanguinanti, le calze rotte, il vestito sporco. Era caduta su per il Montirozzo — così si chiama una parte delle mura medievali di Jesi — tornando proprio dal mercato. In mano due buste piene di roba. Intatte. Costretta a scegliere se salvare la spesa o le ginocchia, Nenella non aveva esitato a sacrificare la pelle. Perlomeno un pezzetto.
Ma non è l’unica.
«Ogni tanto c’è qualche signora che casca per le scale del mercato, quelle che portano dal piano di sopra a quello di sotto. Capita di vedere macchie di sangue mentre scendi» dice lei ridendo. E chissà se pure loro sacrificano un gomito o un ginocchio piuttosto che la spesa.
Da qualche anno, oltre alle scale, per scendere al piano inferiore c’è pure un’ascensore, che si affaccia su Via Mercantini, recentemente protagonista di un’imponente opera di riqualificazione.
Un tempo lì c’era una sede distaccata del Liceo Scientifico, tutte le classi del biennio pericolosamente sopra ad un deposito di bombole del gas. Io ci andavo a scuola e di tanto in tanto, la mattina, quando la corriera mi lasciava giusto davanti all’entrata superiore del mercato, passavo in mezzo ai contadini e agli ambulanti e andavo a comprare un pezzo di pizza per la merenda.
Sulle scale c’era pure l’appuntamento con quelli che avevano deciso di fare saltamento, marinare la scuola, e dalla piazzetta sottostante partivano i cortei degli scioperi, tra i commenti piccati delle vecchiette che si erano alzate presto per andare a far spesa, o la solidarietà di qualche pensionato che si esaltava appena vedeva falce e martello dipinti malamente su uno striscione.
Ora la scuola è stata demolita per costruire case, negozi e uffici color melograno, la maggior parte dei quali ha ancora cartelli attaccati sopra con su scritto Vendesi o Affittasi.
Gli stessi banchi del Mercato delle Erbe, oggi, sono molti di meno rispetto a quello che c’erano quando facevo il liceo. «Ce n’erano più del doppio» conferma mia nonna, testimone di una città che sta via via perdendo la sua identità, a partire proprio dal centro storico.
C’è chi dà la colpa alle ondate di immigrazione, che in due grandi flussi, il primo negli anni ’90, il secondo negli ultimi dieci anni, hanno ridisegnato la demografia jesina. Ma a vedere i volti di chi frequenta il mercato — perlopiù anziani, qualche giovane coppia, tante donne e uomini dai tratti slavi, albanesi, nordafricani — credo che il problema stia da un’altra parte.
Nei parcheggi enormi e sempre pieni dei centri commerciali spuntati come funghi nella periferia della città, lungo le grandi arterie stradali che si riempiono di auto alla chiusura di fabbriche e uffici; nelle melanzane insapori che arrivano da chissà dove; nei guantini sterili e nelle casse veloci, dove riempire borse biodegradabili di surgelati e piatti pronti. Vietato l’assaggio.
Niente parola d’onore del contadino che ti assicura che il cocomero è dolce e non si sfarina e se glielo chiedi ti fa pure il tassello per fartelo provare.
La grande distribuzione ti velocizza la vita, almeno apparentemente. Ma se le pesche sono acerbe ed il melone sa di cartone sono affari tuoi.
«Davvero non ti fanno lo sconto?» chiede di nuovo mia nonna mentre ce ne torniamo a casa, le borse piene di odori, colori e sapori del territorio, stando ben attenti a non inciampare, pronti, nel caso, a salvare innanzitutto la spesa.
Un tempo lì c’era una sede distaccata del Liceo Scientifico, tutte le classi del biennio pericolosamente sopra ad un deposito di bombole del gas. Io ci andavo a scuola e di tanto in tanto, la mattina, quando la corriera mi lasciava giusto davanti all’entrata superiore del mercato, passavo in mezzo ai contadini e agli ambulanti e andavo a comprare un pezzo di pizza per la merenda.
Sulle scale c’era pure l’appuntamento con quelli che avevano deciso di fare saltamento, marinare la scuola, e dalla piazzetta sottostante partivano i cortei degli scioperi, tra i commenti piccati delle vecchiette che si erano alzate presto per andare a far spesa, o la solidarietà di qualche pensionato che si esaltava appena vedeva falce e martello dipinti malamente su uno striscione.
Ora la scuola è stata demolita per costruire case, negozi e uffici color melograno, la maggior parte dei quali ha ancora cartelli attaccati sopra con su scritto Vendesi o Affittasi.
Gli stessi banchi del Mercato delle Erbe, oggi, sono molti di meno rispetto a quello che c’erano quando facevo il liceo. «Ce n’erano più del doppio» conferma mia nonna, testimone di una città che sta via via perdendo la sua identità, a partire proprio dal centro storico.
C’è chi dà la colpa alle ondate di immigrazione, che in due grandi flussi, il primo negli anni ’90, il secondo negli ultimi dieci anni, hanno ridisegnato la demografia jesina. Ma a vedere i volti di chi frequenta il mercato — perlopiù anziani, qualche giovane coppia, tante donne e uomini dai tratti slavi, albanesi, nordafricani — credo che il problema stia da un’altra parte.
Nei parcheggi enormi e sempre pieni dei centri commerciali spuntati come funghi nella periferia della città, lungo le grandi arterie stradali che si riempiono di auto alla chiusura di fabbriche e uffici; nelle melanzane insapori che arrivano da chissà dove; nei guantini sterili e nelle casse veloci, dove riempire borse biodegradabili di surgelati e piatti pronti. Vietato l’assaggio.
Niente parola d’onore del contadino che ti assicura che il cocomero è dolce e non si sfarina e se glielo chiedi ti fa pure il tassello per fartelo provare.
La grande distribuzione ti velocizza la vita, almeno apparentemente. Ma se le pesche sono acerbe ed il melone sa di cartone sono affari tuoi.
«Davvero non ti fanno lo sconto?» chiede di nuovo mia nonna mentre ce ne torniamo a casa, le borse piene di odori, colori e sapori del territorio, stando ben attenti a non inciampare, pronti, nel caso, a salvare innanzitutto la spesa.