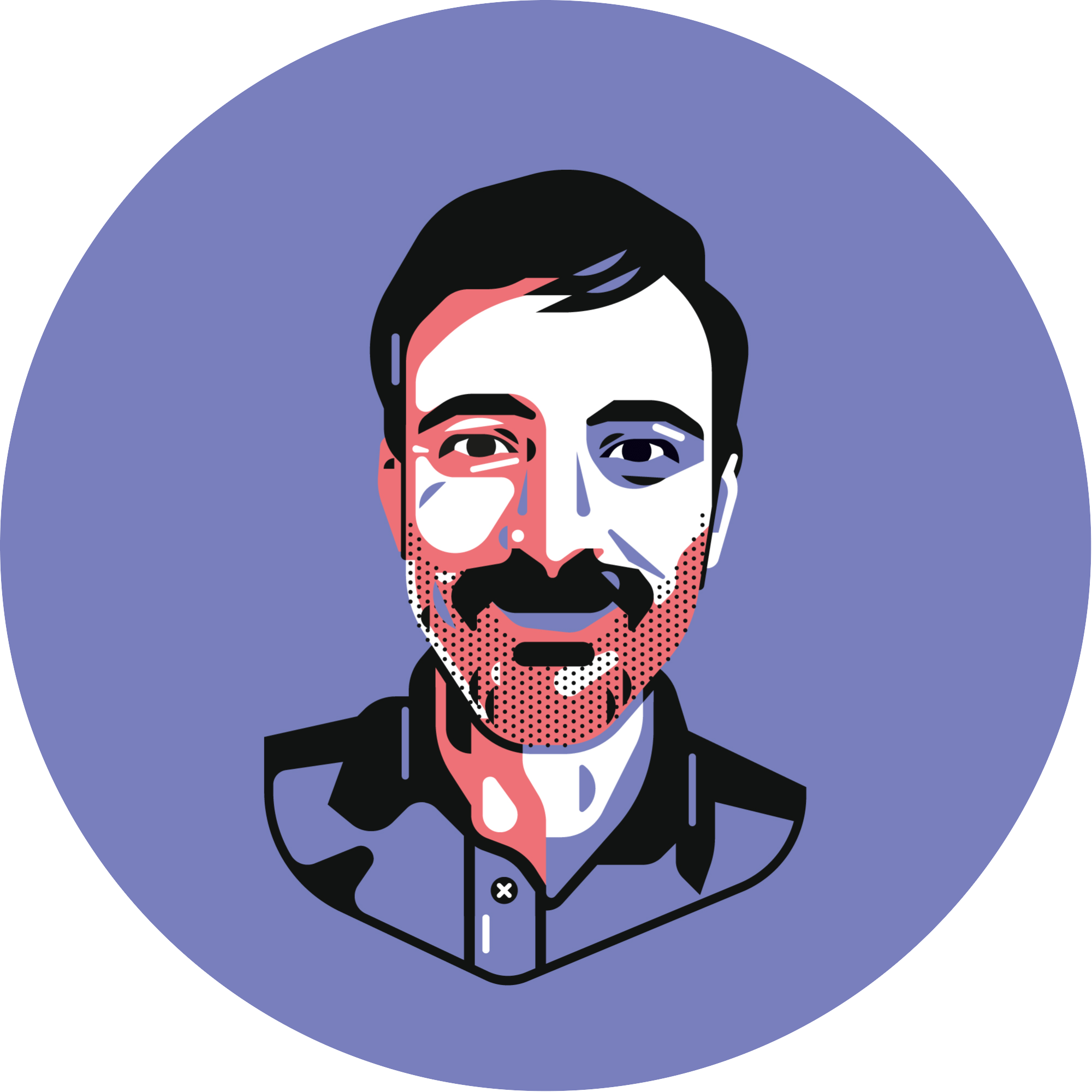Gli occhi di Gesù
C'era questa scala a chiocciola, di metallo, verniciata di rosso acceso. Era un rosso “allarme”, tipicamente anni '70, e non c'entrava niente col resto della stanza e della casa. Aveva un corrimano di plastica nera, vagamente morbido, quasi gommoso, e le pedate dei gradini erano pure nere, zigrinate, per far presa sulle suole delle scarpe e impedirti di scivolare giù, ma che sui calzini o sui piedi nudi, se capitava di scendere in garage d'estate, lasciava una graticola di segni che spariva dopo qualche minuto, assieme al fastidio.
La stanza che ospitava la scala per anni non servì a niente. C'era una finestra che dava sul giardino, c'era un tavolo marrone chiaro, lucido, quadrato e con un cassetto, c'era un armadio porta scarpe e una libreria che dava sulla gabbia della scala. Lì tenevamo i libri di cucina, i manuali, il cestino del cucito. Dietro a uno sportello c’erano le medicine e dietro all'altro i giocattoli che usavo poco.
L’unica, effettiva funzione della stanza, nonostante fosse abbastanza grande da poterci mettere dentro un piccolo salotto o una camera da letto, era di ospitare la scala rossa che portava in garage. Di lì si scendeva giù di almeno tre metri e mezzo, forse quattro metri, e si arrivava a una piccola anticamera da cui, attraverso una porta, si entrava in garage.
Di sera, prima di andare a dormire, quella porta veniva chiusa rigorosamente a chiave, come pure la porta della stanza di sopra, quella della scala, che chiamavamo “la stanzetta”. Era molto importante che fossero chiuse entrambe e, se per caso capitava che qualcuno se ne dimenticasse, l'indomani mattina, a colazione, si faceva notare la svista non tanto con severità ma comunque con una certa fermezza. A un certo punto, quando mettemmo le inferriate su tutte le finestre della casa, e non molto tempo dopo mio padre comprò anche una pistola, laggiù, sulla porta che conduceva in garage, facemmo mettere un cancello a scorrimento orizzontale. Quando veniva chiuso, la sera, la chiave andava appoggiata XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX (mi spiace ma era ed è ancora un segreto di famiglia), il più lontano possibile dalla porta, sì che nessun umano sprovvisto di un bastone con su attaccata una calamita potesse arrivarci.
Succedeva, anche se molto raramente in effetti, di dover andare fin laggiù la sera dopocena o, peggio, in piena notte. Quando capitava, tutto quel girare di chiavi e far rotolare il cancello sui suoi binari, ripetuto per due volte, andata e ritorno, era quantomeno grottesco. E dal mio letto — io dormivo proprio di fronte alla stanzetta — tendevo l'orecchio e seguivo ogni singola fase di quell'insolito rituale, eseguito sempre e comunque con un misto di malavoglia, rapidità e cautela: seguivo ogni passo, ogni scricchiolio della scala, ogni serratura che scattava, e in quei momenti mi pareva di sentire il sapore del ferro della cancellata sulla lingua.
Comunque in garage, di notte, era meglio non andare, su questo concordavamo tutti.
Se per esempio c’era una cena e arrivavano ospiti, il cancello scorrevole là sotto veniva chiuso prima che arrivassero, ovviamente dopo aver portato su le bottiglie di vino necessarie. C’era un’intera parete piena di nicchie rotonde e regolari, laggiù, ciascuna larga quanto una bottiglia, e di bottiglie ne avevamo tante, tra cui alcune piene di polvere che erano lì da chissà quanto e che mio padre qualche volta, quando c’ero anche io, prendeva, leggeva le etichette, fantasticava su chissà cosa e poi le rimetteva a posto, dicendo: «Questa la apriamo per un occasione speciale».
Se la cena con gli ospiti andava particolarmente bene e tutto il vino in cucina finiva, oppure l’atmosfera era tanto elettrica da meritare che venisse aperta una delle bottiglie di grappa speciali, allora bisognava scendere giù, aprire il cancello, accendere la luce, sempre con rapidità, sempre con cautela, e risalire in fretta dopo aver chiuso. Quando succedeva sia io che mia madre stavamo con le orecchie ben diritte, per captare ogni rumore, finché mio padre non risaliva. Gli ospiti, che non lo sapevano, probabilmente giudicavano buffo il nostro modo di comportarci, ma di solito a quel punto avevano già bevuto e non ci facevano caso. Se c’erano anche bambini, loro se ne accorgevano, tranne se erano proprio piccoli piccoli.
Una volta Stefano me lo chiese: «Che c’è di sotto?».
Stefano era quello che una volta, quando coi miei andammo a cena a casa sua, mi raccontò che nel suo isolato di notte andava in giro un branco di cani randagi. Questi cani erano grossi e attaccavano le persone. Si sentiva pure ululare, in effetti, proprio mentre lui me lo diceva.
«State attenti quando andate a casa» disse quando io e lui giocavamo, da soli, in camera sua, mentre i grandi erano di là, oltre il corridoio, che ridevano.
Io e Stefano a scuola ci mettevamo spesso vicini a disegnare. Era una scuola particolare: non ufficialmente montessoriana ma che ne applicava gran parte dei metodi. Imparammo quasi tutti a leggere molto presto. C’erano solo tre classi in quella scuola, ma non erano divise per età, così i più grandi davano una mano ai più piccoli, si costruiva assieme, ci si imbrattava di vernice. Noi grandi leggevamo persino le storie ai piccoli, ma solo al pomeriggio.
Disegnavamo molti cavalli, io e Stefano. «Metti le sopracciglia» diceva lui. «I cavalli hanno le sopracciglia. Mettile, mi raccomando».
Le mettevamo entrambi, pelossisime. Sopracciglia importanti come quelle dei vecchi saggi dei cartoni animati.
Io invece ero bravo a disegnare le tigri fatte a pezzi. Ero bravo perché i pezzetti di tigre erano piccoli piccoli ma si riconosceva comunque che era un tigre. Un occhio di qua, uno di là, i denti, le orecchie, il muso, le zampette, divise in almeno tre o quattro frammenti, la coda anche di più, tutto sparpagliato sul foglio e con tanto sangue rosso che usciva da ogni parte. Non lo so mica perché le disegnavo. Non avevo visto nessun animale fatto a pezzi, a parte forse qualche insetto, ma in ogni caso non ci sarebbe stato sangue, comunque non rosso come il nostro. Non so neanche se la maestra ne parlò mai ai miei genitori, che tuttavia lo sapevano benissimo perché li portavo anche a casa quei disegni.
A un certo punto io e Stefano cominciammo a fare a pezzi pure i cavalli. Gli uomini invece no. Li facevamo muscolosissimi, solitamente in mutande, con gli addominali a tartaruga e tutto quanto, e li riempivamo di tagli e di schizzi di sangue ma li lasciavamo sempre con tutte le gambe e le braccia e la testa e gli occhi attaccati (ma quand'erano di profilo, in effetti, non si può mai sapere).
Appeso sopra al suo letto, Stefano aveva un ritratto di Gesù. Me lo spiegò lui che era Gesù perché io non lo sapevo: noi in famiglia non andavamo in chiesa, i miei non erano credenti e la mia prima preghiera — Atto di dolore, mio Dio mi pento e mi dolgo... mi piaceva tantissimo quella parola, dolgo — la recitai durante l’estate subito dopo la fine della prima elementare, quando mia zia Catia mi portò a catechismo e scoprii, tra l’altro, che tutti i miei compagni di scuola la domenica si vedevano lì.
Quello di Gesù era un quadretto piccolo, senza cornice, appeso con un gancino dorato. Sembrava esser stato dipinto direttamente sul legno. Il problema erano gli occhi: quel ritratto ti fissava. Lo faceva in modo strano, come nessun altro sguardo avessi visto fino a quel momento.
Chiesi a Stefano se poteva voltarlo. Intendevo dire proprio girarlo dall’altra parte, faccia al muro o, ancora meglio, toglierlo del tutto. Non mi faceva sentire bene che quegli occhi mi guardassero così. Stefano però non ci arrivava a toglierlo, probabilmente nemmeno salendo sul letto. E comunque, come con la storia dei cani, avendo l’occasione di spaventarmi, ovviamente la sfruttava. L’avrei fatto anch’io.
(Qualche anno dopo, quello stesso identico quadretto lo ritrovai in camera di Andrea, un mio amico delle elementari e poi anche delle medie. «Non ti fanno paura quegli occhi?», chiesi un pomeriggio ad Andrea dopo aver rimuginato quel pensiero per un po'. «No, perché?». E a quel punto cominciò pure lui a guardarli bene gli occhi di Gesù, e lo percepii benissimo il suo disagio. Sembrava scavarti fino in fondo al cervello, quello sguardo, e poi oltre. Pareva vedesse qualcosa di te che tu però non riuscivi a vedere. Andrea, a differenza di Stefano, lo voltò faccia al muro. Giocammo per un po’ ma a un certo punto i nostri pensieri tornarono lì, al quadro capovolto. Non vederlo, quello sguardo, era ancora peggio che averlo puntato in faccia, quasi potesse fare qualcosa a nostra insaputa. Quindi continuavamo a sbirciare lì sotto, sollevandolo un poco dal muro, per poi rimetterlo a posto e così via, finché non arrivò la madre di Andrea e ci sgridò perché «Non si gioca con Gesù». Quando tornai a casa mi chiesi come avrebbe fatto, Andrea, quella notte).
Stefano, pure, non so come facesse. Io non sarei mai riuscito a dormire con quello nella stanza. Né sapendo di averlo da qualche altra parte, tipo in salotto, in cucina, nella stanzetta.
«Saranno stati almeno dieci!», Stefano mi stava raccontando che un po’ di tempo prima un ragazzo del quartiere era stato attaccato dai cani.
Il ragazzo l’avevano ritrovato il giorno dopo, tra le colonne. Sbranato.
Sbranato.
E intanto gli ululati dei cani continuavano, mentre l'aria, di là, dai nostri genitori, si era fatta elettrica.
Chissà se il padre di Stefano aveva la grappa. Chissà se aveva le bottiglie impolverate e anche lui le avrebbe aperte quando sarebbe arrivata l'occasione. E chissà dove le teneva le bottiglie. E da dove sarebbe arrivata l'occasione. Chissà se con la spada di plastica sarei riuscito ad arrivare al quadretto di Gesù.
«Sei stanco?» chiese mia madre che era venuta a controllare. In effetti sì, ero stanco, ma non l’avrei mai ammesso perché speravo non dover mai uscire da quella casa, perlomeno non di notte, coi cani randagi che sbranavano.
Se li avessi avvertiti, i miei genitori, che avrebbero fatto? Saremmo rimasti tutti a dormire lì? Sarei riuscito anche a convincere qualcuno dei grandi a togliere Gesù?
Ma non ebbi il coraggio di dirlo alla mamma, che se tornò di là, dove ricominciarono a ridere. Avrei voluto che le risate continuassero per tutta la notte o perlomeno fin quando non mi fossi addormentato io. E credo che alla fine mi addormentai.
La stanza che ospitava la scala per anni non servì a niente. C'era una finestra che dava sul giardino, c'era un tavolo marrone chiaro, lucido, quadrato e con un cassetto, c'era un armadio porta scarpe e una libreria che dava sulla gabbia della scala. Lì tenevamo i libri di cucina, i manuali, il cestino del cucito. Dietro a uno sportello c’erano le medicine e dietro all'altro i giocattoli che usavo poco.
L’unica, effettiva funzione della stanza, nonostante fosse abbastanza grande da poterci mettere dentro un piccolo salotto o una camera da letto, era di ospitare la scala rossa che portava in garage. Di lì si scendeva giù di almeno tre metri e mezzo, forse quattro metri, e si arrivava a una piccola anticamera da cui, attraverso una porta, si entrava in garage.
Di sera, prima di andare a dormire, quella porta veniva chiusa rigorosamente a chiave, come pure la porta della stanza di sopra, quella della scala, che chiamavamo “la stanzetta”. Era molto importante che fossero chiuse entrambe e, se per caso capitava che qualcuno se ne dimenticasse, l'indomani mattina, a colazione, si faceva notare la svista non tanto con severità ma comunque con una certa fermezza. A un certo punto, quando mettemmo le inferriate su tutte le finestre della casa, e non molto tempo dopo mio padre comprò anche una pistola, laggiù, sulla porta che conduceva in garage, facemmo mettere un cancello a scorrimento orizzontale. Quando veniva chiuso, la sera, la chiave andava appoggiata XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX (mi spiace ma era ed è ancora un segreto di famiglia), il più lontano possibile dalla porta, sì che nessun umano sprovvisto di un bastone con su attaccata una calamita potesse arrivarci.
Succedeva, anche se molto raramente in effetti, di dover andare fin laggiù la sera dopocena o, peggio, in piena notte. Quando capitava, tutto quel girare di chiavi e far rotolare il cancello sui suoi binari, ripetuto per due volte, andata e ritorno, era quantomeno grottesco. E dal mio letto — io dormivo proprio di fronte alla stanzetta — tendevo l'orecchio e seguivo ogni singola fase di quell'insolito rituale, eseguito sempre e comunque con un misto di malavoglia, rapidità e cautela: seguivo ogni passo, ogni scricchiolio della scala, ogni serratura che scattava, e in quei momenti mi pareva di sentire il sapore del ferro della cancellata sulla lingua.
Comunque in garage, di notte, era meglio non andare, su questo concordavamo tutti.
Se per esempio c’era una cena e arrivavano ospiti, il cancello scorrevole là sotto veniva chiuso prima che arrivassero, ovviamente dopo aver portato su le bottiglie di vino necessarie. C’era un’intera parete piena di nicchie rotonde e regolari, laggiù, ciascuna larga quanto una bottiglia, e di bottiglie ne avevamo tante, tra cui alcune piene di polvere che erano lì da chissà quanto e che mio padre qualche volta, quando c’ero anche io, prendeva, leggeva le etichette, fantasticava su chissà cosa e poi le rimetteva a posto, dicendo: «Questa la apriamo per un occasione speciale».
Se la cena con gli ospiti andava particolarmente bene e tutto il vino in cucina finiva, oppure l’atmosfera era tanto elettrica da meritare che venisse aperta una delle bottiglie di grappa speciali, allora bisognava scendere giù, aprire il cancello, accendere la luce, sempre con rapidità, sempre con cautela, e risalire in fretta dopo aver chiuso. Quando succedeva sia io che mia madre stavamo con le orecchie ben diritte, per captare ogni rumore, finché mio padre non risaliva. Gli ospiti, che non lo sapevano, probabilmente giudicavano buffo il nostro modo di comportarci, ma di solito a quel punto avevano già bevuto e non ci facevano caso. Se c’erano anche bambini, loro se ne accorgevano, tranne se erano proprio piccoli piccoli.
Una volta Stefano me lo chiese: «Che c’è di sotto?».
Stefano era quello che una volta, quando coi miei andammo a cena a casa sua, mi raccontò che nel suo isolato di notte andava in giro un branco di cani randagi. Questi cani erano grossi e attaccavano le persone. Si sentiva pure ululare, in effetti, proprio mentre lui me lo diceva.
«State attenti quando andate a casa» disse quando io e lui giocavamo, da soli, in camera sua, mentre i grandi erano di là, oltre il corridoio, che ridevano.
Io e Stefano a scuola ci mettevamo spesso vicini a disegnare. Era una scuola particolare: non ufficialmente montessoriana ma che ne applicava gran parte dei metodi. Imparammo quasi tutti a leggere molto presto. C’erano solo tre classi in quella scuola, ma non erano divise per età, così i più grandi davano una mano ai più piccoli, si costruiva assieme, ci si imbrattava di vernice. Noi grandi leggevamo persino le storie ai piccoli, ma solo al pomeriggio.
Disegnavamo molti cavalli, io e Stefano. «Metti le sopracciglia» diceva lui. «I cavalli hanno le sopracciglia. Mettile, mi raccomando».
Le mettevamo entrambi, pelossisime. Sopracciglia importanti come quelle dei vecchi saggi dei cartoni animati.
Io invece ero bravo a disegnare le tigri fatte a pezzi. Ero bravo perché i pezzetti di tigre erano piccoli piccoli ma si riconosceva comunque che era un tigre. Un occhio di qua, uno di là, i denti, le orecchie, il muso, le zampette, divise in almeno tre o quattro frammenti, la coda anche di più, tutto sparpagliato sul foglio e con tanto sangue rosso che usciva da ogni parte. Non lo so mica perché le disegnavo. Non avevo visto nessun animale fatto a pezzi, a parte forse qualche insetto, ma in ogni caso non ci sarebbe stato sangue, comunque non rosso come il nostro. Non so neanche se la maestra ne parlò mai ai miei genitori, che tuttavia lo sapevano benissimo perché li portavo anche a casa quei disegni.
A un certo punto io e Stefano cominciammo a fare a pezzi pure i cavalli. Gli uomini invece no. Li facevamo muscolosissimi, solitamente in mutande, con gli addominali a tartaruga e tutto quanto, e li riempivamo di tagli e di schizzi di sangue ma li lasciavamo sempre con tutte le gambe e le braccia e la testa e gli occhi attaccati (ma quand'erano di profilo, in effetti, non si può mai sapere).
Appeso sopra al suo letto, Stefano aveva un ritratto di Gesù. Me lo spiegò lui che era Gesù perché io non lo sapevo: noi in famiglia non andavamo in chiesa, i miei non erano credenti e la mia prima preghiera — Atto di dolore, mio Dio mi pento e mi dolgo... mi piaceva tantissimo quella parola, dolgo — la recitai durante l’estate subito dopo la fine della prima elementare, quando mia zia Catia mi portò a catechismo e scoprii, tra l’altro, che tutti i miei compagni di scuola la domenica si vedevano lì.
Quello di Gesù era un quadretto piccolo, senza cornice, appeso con un gancino dorato. Sembrava esser stato dipinto direttamente sul legno. Il problema erano gli occhi: quel ritratto ti fissava. Lo faceva in modo strano, come nessun altro sguardo avessi visto fino a quel momento.
Chiesi a Stefano se poteva voltarlo. Intendevo dire proprio girarlo dall’altra parte, faccia al muro o, ancora meglio, toglierlo del tutto. Non mi faceva sentire bene che quegli occhi mi guardassero così. Stefano però non ci arrivava a toglierlo, probabilmente nemmeno salendo sul letto. E comunque, come con la storia dei cani, avendo l’occasione di spaventarmi, ovviamente la sfruttava. L’avrei fatto anch’io.
(Qualche anno dopo, quello stesso identico quadretto lo ritrovai in camera di Andrea, un mio amico delle elementari e poi anche delle medie. «Non ti fanno paura quegli occhi?», chiesi un pomeriggio ad Andrea dopo aver rimuginato quel pensiero per un po'. «No, perché?». E a quel punto cominciò pure lui a guardarli bene gli occhi di Gesù, e lo percepii benissimo il suo disagio. Sembrava scavarti fino in fondo al cervello, quello sguardo, e poi oltre. Pareva vedesse qualcosa di te che tu però non riuscivi a vedere. Andrea, a differenza di Stefano, lo voltò faccia al muro. Giocammo per un po’ ma a un certo punto i nostri pensieri tornarono lì, al quadro capovolto. Non vederlo, quello sguardo, era ancora peggio che averlo puntato in faccia, quasi potesse fare qualcosa a nostra insaputa. Quindi continuavamo a sbirciare lì sotto, sollevandolo un poco dal muro, per poi rimetterlo a posto e così via, finché non arrivò la madre di Andrea e ci sgridò perché «Non si gioca con Gesù». Quando tornai a casa mi chiesi come avrebbe fatto, Andrea, quella notte).
Stefano, pure, non so come facesse. Io non sarei mai riuscito a dormire con quello nella stanza. Né sapendo di averlo da qualche altra parte, tipo in salotto, in cucina, nella stanzetta.
«Saranno stati almeno dieci!», Stefano mi stava raccontando che un po’ di tempo prima un ragazzo del quartiere era stato attaccato dai cani.
Il ragazzo l’avevano ritrovato il giorno dopo, tra le colonne. Sbranato.
Sbranato.
E intanto gli ululati dei cani continuavano, mentre l'aria, di là, dai nostri genitori, si era fatta elettrica.
Chissà se il padre di Stefano aveva la grappa. Chissà se aveva le bottiglie impolverate e anche lui le avrebbe aperte quando sarebbe arrivata l'occasione. E chissà dove le teneva le bottiglie. E da dove sarebbe arrivata l'occasione. Chissà se con la spada di plastica sarei riuscito ad arrivare al quadretto di Gesù.
«Sei stanco?» chiese mia madre che era venuta a controllare. In effetti sì, ero stanco, ma non l’avrei mai ammesso perché speravo non dover mai uscire da quella casa, perlomeno non di notte, coi cani randagi che sbranavano.
Se li avessi avvertiti, i miei genitori, che avrebbero fatto? Saremmo rimasti tutti a dormire lì? Sarei riuscito anche a convincere qualcuno dei grandi a togliere Gesù?
Ma non ebbi il coraggio di dirlo alla mamma, che se tornò di là, dove ricominciarono a ridere. Avrei voluto che le risate continuassero per tutta la notte o perlomeno fin quando non mi fossi addormentato io. E credo che alla fine mi addormentai.