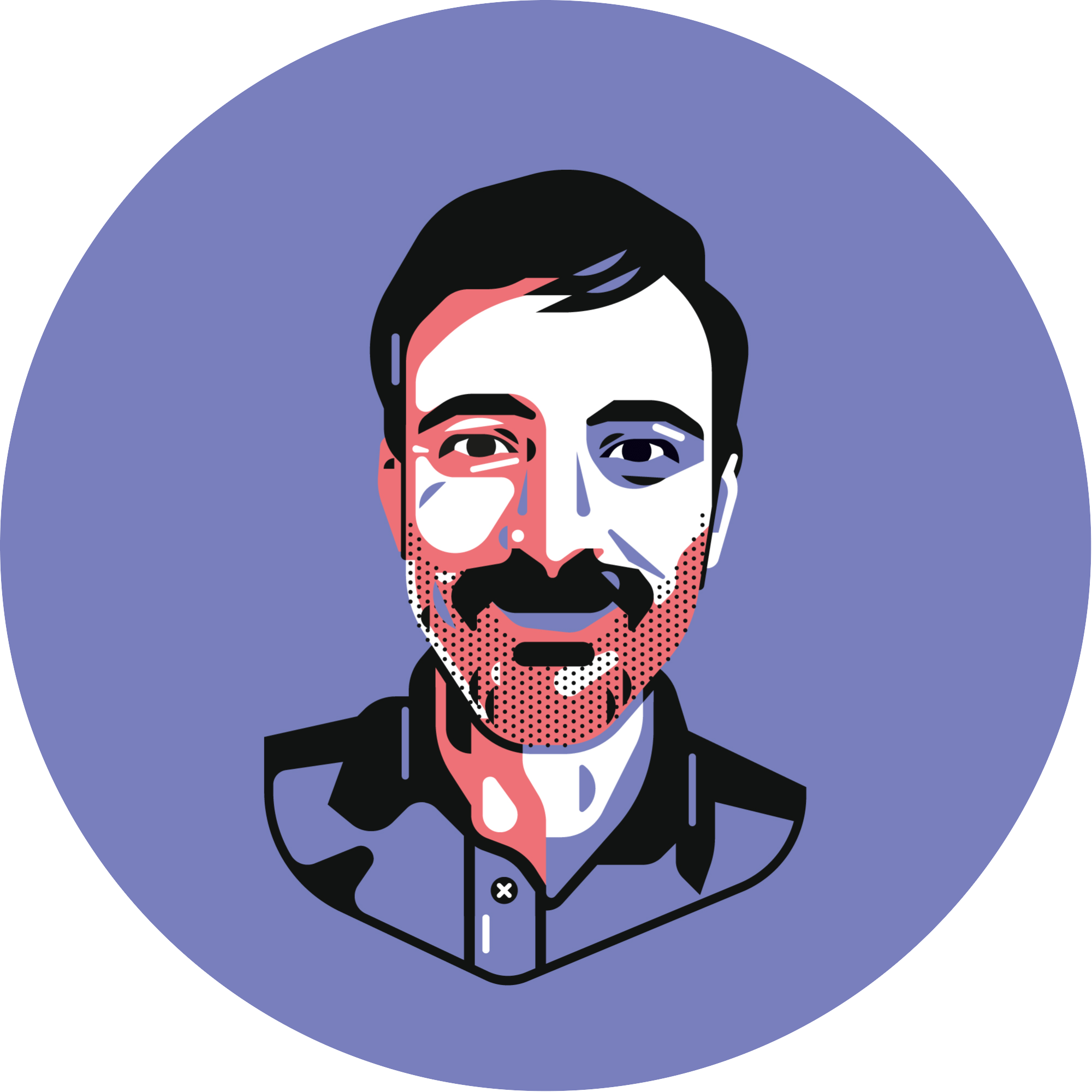La casa delle urla
La casa delle urla la costruì mio nonno. Falegname sempre abbronzato — non si sa come: non andava al mare, lavorava nella sua bottega e quasi mai all’aperto, a meno che non avesse passato gli ultimi suoi anni di vita a fabbricare in gran segreto casette di legno come la mia, fatto del quale non mi meraviglierei affatto, almeno dai racconti che ho sentito su di lui dopo la sua morte, ma visto che nella mia famiglia nessuno ne sa qualcosa, a meno che i soliti noti non abbiano deciso di chiudere il becco per pigrizia, contegno, scarso o assente senso del dovere di tramandare se non in forma scritta (figuriamoci!) almeno attraverso qualche accenno buttato lì durante le rare riunioni di famiglia (inevitabili e accidentali come un funerale, o tiepidamente attese e forzose come un matrimonio o un battesimo) gli scampoli di storia rimasti fuori dalle trame lineari della saga familiare, che tuttora mi trovo a riscoprire, con non poca fatica, e a cucire insieme con risultati patetici tanto quanto le coperte patchwork che mia zia Corradina si ostinava a regalare a cugini, nipoti e pronipoti, preferibili comunque ai pasticci di ricotta che imponeva durante i vocianti pranzi natalizi e che nessuno, per cortesia e buon cuore, aveva mai il coraggio di rifiutare, e chissà mio nonno, che forse lui era l’unico ad aver quel tatto furbo da artigiano, i modi da upper class proletaria per declinar l’offerta senza offendere l’orgoglio patrizio di quella miniatura di donna che sembrava passata direttamente dalla spensierata giovinezza a una vecchiezza acciaccata e storta, e che, non avendo mai timbrato cartellini né provato su quella sua pelle trasparente e asciutta da pesca secca un’ora che sia una di lavoro, non aveva il minimo anticorpo contro rifiuti e osservazioni, ma pure questo forse rimarrà oscuro come la notte senza stelle in cui mi trovo a buttar giù la storia in cui ti ho trascinato, e mai racconto al riguardo ho ascoltato, nemmeno al suo stato minimo, quell’ “e” che congiungendo un nome a un altro sottintende o almeno insinua che uno possa aver parlato a, pranzato con, anche solo incontrato l’altra, perciò in questo, come in mille altri casi, lascio parlar gli indizi, rievoco (o immagino) i non detti e mi lascio andare a un ricordo verosimile: il pranzo di Natale in cui mio nonno eroicamente rifiutò il pasticcio di ricotta di zia Corradina andando ad aggiungere l’ennesimo, solido mattone al monumento postumo che tutti noi saremmo poi andati ad erigere idealmente in suo onore, e ad evocar l’un l’altro (nonché a presentare in tutta la sua mitica imponenza all’estraneo che si fosse trovato a passar di là per caso o per senso del dovere di familiare che per sangue, o via via scendendo di grado, amore o amicizia, si fosse trovato ad arrivar troppo tardi, per svantaggio d’anagrafe, ai banchetti a cui il grand’uomo ha potuto partecipare, bocca, gola, mani e stomaco in persona), pranzo in cui il sottoscritto, che non aveva ancora ricevuto il dono della parola, sedeva malamente sul seggiolone tra madre e nonno, lontano da pasticci commestibili e figurati, sbavando minestrine su di un bavaglino troppo grande, la doppia S — assurta ad emblema di famiglia — ricamata con orgoglio dalle dita gonfie di fatica della nonna, quell’Adele dalle gote perennemente rosse, un intreccio di venuzze, una topografia di pazienza e di sforzi che aveva rubato al volto — quanto tempo prima nessuno saprebbe dire — il compito di illuminarsi con sorrisi che chissà come sembravano tenaglie sui cuori di tutti, tant’erano rari e veri, mentre la bocca, questa se ne stava prudentemente piegata verso il basso, agl’angoli, come soggetta ad una gravità tutta sua, sottolineando rassegnati sospiri e invocazioni al cielo che a dirla tutta, insieme alle inimitate ricette, dispensate alle nuore non si sa se per generosità o sadismo, e alle domande retoriche che potevano considerarsi la sua versione del sarcasmo (a Corradina, quante volte, «sei tanto stanca, eh?», a conclusione dei monologhi di quella ed ennesima cannonata in campo avverso di una battaglia silenziosa protrattasi per decenni, che quando finì, per abbandono della secca Corradina, si portò via pure gli ultimi sorrisi di Adele), costituivano gran parte del contributo oratorio della nonna, autoelettasi cameriera, ai pranzi e nella vita, prima per necessità, poi per dovere e infine per piacere, perennemente in viaggio tra tavola e cucina, sfiorata dalle liti di rappresentanza tra quattro o cinque versioni di comunismo, ed altrettanti ego, i cui gomiti forse si sfioravano troppo spesso per non stuzzicarsi ed ingaggiare guerre lampo, tiepide come i cappelletti in brodo avanzati in mezzo al tavolo che lo zio Carlo aspettava si freddassero quel poco che bastava per il bis solitario d’ordinanza, da consumare lentamente, i baffi asciugando con prontezza, col suo impescrutabile sguardo lanciato già verso la poltrona più vicina — casalingo campo d’azione di sogni anarchici e forse donne, forse uomini di cui ricordar labbra e sospiri da portare nella tomba, insieme ai baffi e alla tuta blu da fabbro che nascondeva tutti i muscoli che nessuno gli aveva mai visto addosso, appesa al muro della piccola bottega assieme a martelli d’ogni foggia (finiti chissà dove insieme alle risposte alle domande che nessuno gli ha mai fatto, ma con quegli occhi che aveva in ospedale, rimasti soli insieme a mucchio d’ossa, un po’ di pelle e i soliti capelli tirati all’indietro, non dico che qualcuno avrebbe dovuto) — per il pisolino che incorniciava ogni pranzo di famiglia e chiudeva il sipario alla domenica o alla festa comandata insieme al concerto per sole voci femminili e piatti sporchi che dalla cucina arrivava fino al lettone dove io e le mie cugine, ben coperti e a occhi chiusi, sperimentavamo il volo a braccia aperte, decollando in fase REM e planando non visti tra le stanze della casa, fino ai riccioli di fumo, al russare e alla tv, che accompagnava sogni che a differenza dei nostri conoscevano i problemi ma non le soluzioni, e raramente volavano come noi fuori dalle finestre bianche, sopra agli alberi del viale, alle macchine ferme e a quel sole d’inverno che sembrava non riuscire ad arrivar per terra, tra nuvole, tetti rossi e la cappa di noia, spessa come una trapunta, di una città cullata dalle colline tutt’attorno, sopra ad una delle quali, un giorno e chissà perché, in appena due metri quadri rubati al verde del giardino di casa mia, nella casetta di legno costruita da mio nonno, cominciarono le urla, e adesso c’è mia figlia, altra doppia S ricamata, che mi chiede di chi siano quelle voci e perché gridino e se ce l’abbiano con lei, e corre piangendo dalla mamma, che come tutti gli altri, a parte me, le urla non le ha mai sentite, il cuore che rimbomba, la testa piena di domande, le risposte (un giorno lo saprà) da cercare con le lacrime agli occhi tra quelle grida, col tempo tanto familiari, che ti gelano le ossa.