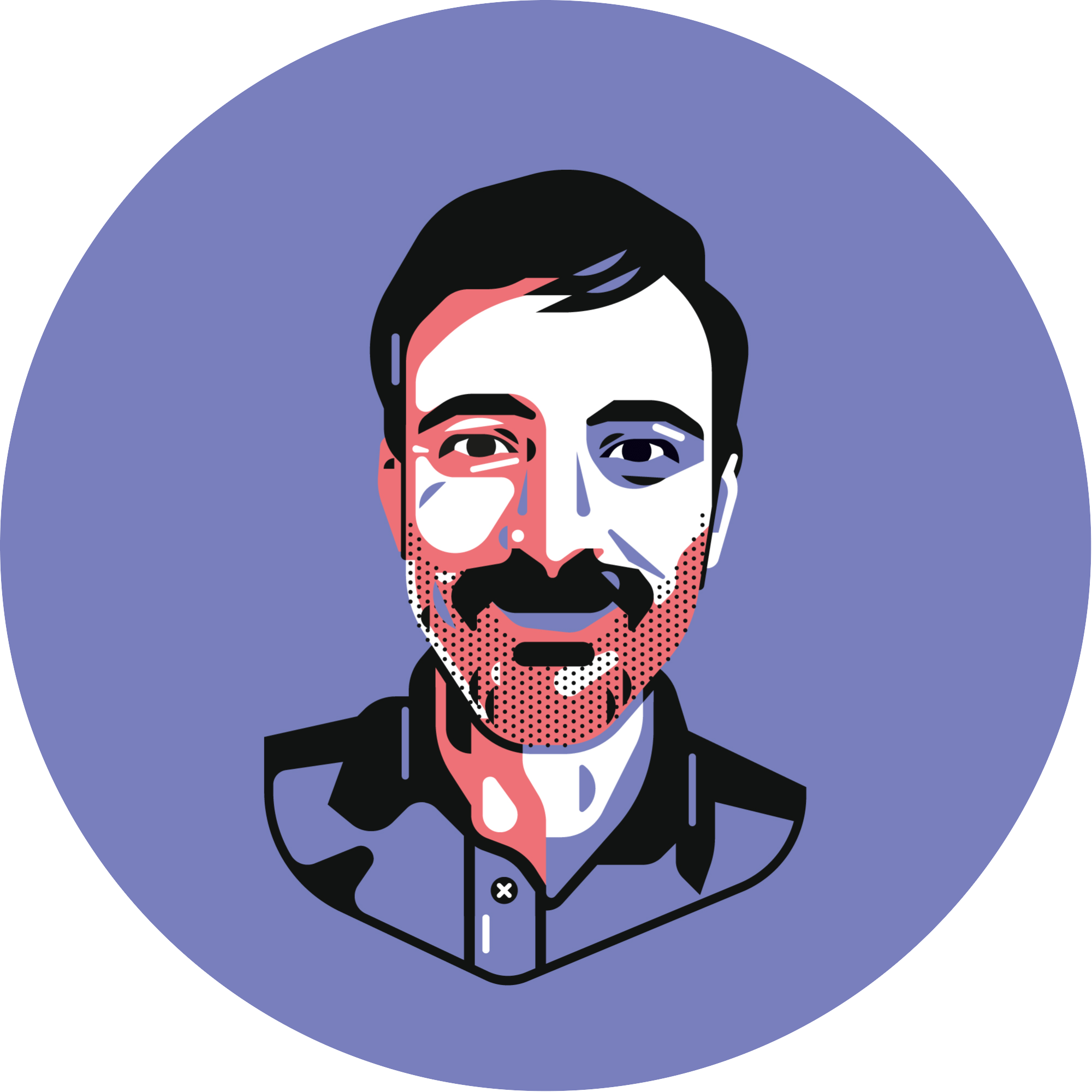Fermare le nuvole
«Basta gridare “Sipario!” e ogni cosa scomparirà come da un palcoscenico.»
(John Berger)
A volte riesco a fermare le nuvole. Me ne sono accorto per caso, quando ancora fumavo sigarette e, visto che in casa c'erano le bambine, preferivo andare a fumare sul balcone o scendere giù nel cortile.
Le mie pause sigaretta erano parentesi vuote. Stavo lì e non pensavo. Semplicemente, guardavo. La pavimentazione del cortile, la casa dirimpetto, le stelle — nelle notti limpide. Betelgeuse, per esempio. La fissavo a lungo. Per meglio dire, la trapassavo con lo sguardo, come ti insegnano a fare quando vuoi vedere le forme tridimensionali dentro ai quei pattern intricati che sono gli stereogrammi. Devi guardare al di là dell'immagine per far apparire ciò che dovrebbe apparire. E io guardavo dietro a Betelgeuse — che è un po' un paradosso dato che quel che c'è dietro a Betelgeuse è sempre coperto da Betelgeuse quindi è sia uno spazio reale che immaginario, che oltretutto non è davvero lì dove immaginiamo di vederlo perché, per via delle distanze astronomiche, la luce di Betelgeuse impiega circa 600 anni ad arrivare a noi, e dunque ciò che chiamiamo Betelgeuse non è qualcosa che *è*, qui e ora, ma che *è stato* e che adesso è altrove.
Quando cominci a misurare in anni luce, l'hic et nunc smette di avere senso: o qualcosa è qui, oppure è ora.
Ma è così pure per lo spazio che si nasconde lì dietro? Potendolo soltanto immaginare, ciò che c'è dietro a Betelgeuse non è sottoposto alle leggi della fisica, non ha fotoni, non ha particelle che devono percorrere miliardi di chilometri per arrivare fino a me e quindi è istantaneo. O, al limite, la sua velocità sarà quella del pensiero, che è forse più lenta di quella della luce ma, essendo l'intero tragitto dentro alla mia testa, un pensiero, quando lo penso, è già lì. E quindi anche lo spazio dietro a Betelgeuse è esattamente lì dove lo penso, mentre Betelgeuse no, è già da un'altra parte. Oppure, chissà, magari non è più: essendo una supergigante rossa, arrivata alla fine della sua vita di stella, potrebbe esplodere in ogni istante. Potrebbe anzi già essere esplosa seicento anni fa, portandosi via quel pezzetto di spazio lì dietro che è sia invisibile che visibile, reale e immaginario allo stesso tempo, qui e altrove, ora e nel passato, e mentre provavo a trapassare con lo sguardo Betelgeuse mi sembrava che si gonfiasse e si restringesse, si gonfiasse e si restringesse. Era solo l'effetto dell'atmosfera, lo sapevo, ma ogni volta mi incantavo. E se fosse esplosa in quel momento? Proprio mentre la guardavo? Cioè seicento anni prima o giù di lì. Avrei visto una grande luce, sarei corso a chiamare le bimbe «sveglia, sveglia, è esplosa Betelgeuse!». Le avrei tirate giù dal letto. Avrei indicato col dito.
«Là! La stavo guardando ed è esplosa».
«E adesso?», mi avrebbero chiesto loro.
«Già, adesso che si fa?», mi sarei domandato io.
È stato così, osservando Betelgeuse, che mi sono accorto della cosa delle nuvole. Mentre ero lì coi miei sguardi, una sera, apparve una nuvoletta. Era leggera leggera, come un velo, e illuminata dalla luna. Stava lentamente passando davanti alla costellazione di Orione proprio mentre i miei occhi erano puntati lì, ma quando mi fissai su Betlegeuse la nuvola si fermò.
Congelata.
«Dev'essere altissima se sembra quasi che non si muova», pensai, ma appena pensai la nuvola si mosse. Allora smisi di pensare e tornai a trapassare Betelgeuse con lo sguardo e la nuvola si fermò di nuovo. Ma non stava ferma per molto: ogni volta che distoglievo la mente dallo spazio dietro alla stella, la nuvola tornava a galleggiare nel cielo.
Bastava solo che nella mia mente si affacciasse un altro pensiero, anche minuscolo.
Tenerla ferma, realizzai, era faticoso. Imponeva la più tenace concentrazione, interamente focalizzata su una cosa e una soltanto: una cosa che non c'è ma c'è. Un nulla che può essere pensato.
Mi esercitai molto nel fissare senza pensare, e non sempre ci riuscivo. Ma non era qualcosa che si poteva fare tutte le notti, perché a volte non ci sono nuvole, altre ce ne sono troppe, e poi, a primavera, Betelgeuse va sotto all'orizzonte per ritornare solo in autunno. Quindi ho cominciato a tentare anche con altre stelle, poi sono passato alla Luna, finché sono arrivato a capire che non servono né stelle né pianeti né satelliti. Si può fare anche di giorno, basta che ci sia anche una sola nuvola, e basta attraversare con lo sguardo un punto qualsiasi, oltre la nuvola, trapassando il cielo azzurro, arrivando a ciò che c'è dietro: il nero dello spazio siderale. Lì, nel nero oltre l'azzurro, c'è il punto che fa fermare le nuvole, e la terra e il sole e tutto quanto. Bisogna afferrarlo con gli occhi e non lasciarlo andare più. Quello cercherà di scappare, tenterà di tutto. Mille miliardi di pensieri busseranno alla porta dell'attenzione per cercare di distrarti.
Più a lungo si riesce a tenerlo, quel punto, e più si sta bene. Bene come quando il tempo si ferma e non c'è niente da spiegare, niente da capire, niente da ricordare, niente, davvero, da dire.
Gli occhi di Gesù
C'era questa scala a chiocciola, di metallo, verniciata di rosso acceso. Era un rosso “allarme”, tipicamente anni '70, e non c'entrava niente col resto della stanza e della casa. Aveva un corrimano di plastica nera, vagamente morbido, quasi gommoso, e le pedate dei gradini erano pure nere, zigrinate, per far presa sulle suole delle scarpe e impedirti di scivolare giù, ma che sui calzini o sui piedi nudi, se capitava di scendere in garage d'estate, lasciava una graticola di segni che spariva dopo qualche minuto, assieme al fastidio.
La stanza che ospitava la scala per anni non servì a niente. C'era una finestra che dava sul giardino, c'era un tavolo marrone chiaro, lucido, quadrato e con un cassetto, c'era un armadio porta scarpe e una libreria che dava sulla gabbia della scala. Lì tenevamo i libri di cucina, i manuali, il cestino del cucito. Dietro a uno sportello c’erano le medicine e dietro all'altro i giocattoli che usavo poco.
L’unica, effettiva funzione della stanza, nonostante fosse abbastanza grande da poterci mettere dentro un piccolo salotto o una camera da letto, era di ospitare la scala rossa che portava in garage. Di lì si scendeva giù di almeno tre metri e mezzo, forse quattro metri, e si arrivava a una piccola anticamera da cui, attraverso una porta, si entrava in garage.
Di sera, prima di andare a dormire, quella porta veniva chiusa rigorosamente a chiave, come pure la porta della stanza di sopra, quella della scala, che chiamavamo “la stanzetta”. Era molto importante che fossero chiuse entrambe e, se per caso capitava che qualcuno se ne dimenticasse, l'indomani mattina, a colazione, si faceva notare la svista non tanto con severità ma comunque con una certa fermezza. A un certo punto, quando mettemmo le inferriate su tutte le finestre della casa, e non molto tempo dopo mio padre comprò anche una pistola, laggiù, sulla porta che conduceva in garage, facemmo mettere un cancello a scorrimento orizzontale. Quando veniva chiuso, la sera, la chiave andava appoggiata XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX (mi spiace ma era ed è ancora un segreto di famiglia), il più lontano possibile dalla porta, sì che nessun umano sprovvisto di un bastone con su attaccata una calamita potesse arrivarci.
Succedeva, anche se molto raramente in effetti, di dover andare fin laggiù la sera dopocena o, peggio, in piena notte. Quando capitava, tutto quel girare di chiavi e far rotolare il cancello sui suoi binari, ripetuto per due volte, andata e ritorno, era quantomeno grottesco. E dal mio letto — io dormivo proprio di fronte alla stanzetta — tendevo l'orecchio e seguivo ogni singola fase di quell'insolito rituale, eseguito sempre e comunque con un misto di malavoglia, rapidità e cautela: seguivo ogni passo, ogni scricchiolio della scala, ogni serratura che scattava, e in quei momenti mi pareva di sentire il sapore del ferro della cancellata sulla lingua.
Comunque in garage, di notte, era meglio non andare, su questo concordavamo tutti.
Se per esempio c’era una cena e arrivavano ospiti, il cancello scorrevole là sotto veniva chiuso prima che arrivassero, ovviamente dopo aver portato su le bottiglie di vino necessarie. C’era un’intera parete piena di nicchie rotonde e regolari, laggiù, ciascuna larga quanto una bottiglia, e di bottiglie ne avevamo tante, tra cui alcune piene di polvere che erano lì da chissà quanto e che mio padre qualche volta, quando c’ero anche io, prendeva, leggeva le etichette, fantasticava su chissà cosa e poi le rimetteva a posto, dicendo: «Questa la apriamo per un occasione speciale».
Se la cena con gli ospiti andava particolarmente bene e tutto il vino in cucina finiva, oppure l’atmosfera era tanto elettrica da meritare che venisse aperta una delle bottiglie di grappa speciali, allora bisognava scendere giù, aprire il cancello, accendere la luce, sempre con rapidità, sempre con cautela, e risalire in fretta dopo aver chiuso. Quando succedeva sia io che mia madre stavamo con le orecchie ben diritte, per captare ogni rumore, finché mio padre non risaliva. Gli ospiti, che non lo sapevano, probabilmente giudicavano buffo il nostro modo di comportarci, ma di solito a quel punto avevano già bevuto e non ci facevano caso. Se c’erano anche bambini, loro se ne accorgevano, tranne se erano proprio piccoli piccoli.
Una volta Stefano me lo chiese: «Che c’è di sotto?».
Stefano era quello che una volta, quando coi miei andammo a cena a casa sua, mi raccontò che nel suo isolato di notte andava in giro un branco di cani randagi. Questi cani erano grossi e attaccavano le persone. Si sentiva pure ululare, in effetti, proprio mentre lui me lo diceva.
«State attenti quando andate a casa» disse quando io e lui giocavamo, da soli, in camera sua, mentre i grandi erano di là, oltre il corridoio, che ridevano.
Io e Stefano a scuola ci mettevamo spesso vicini a disegnare. Era una scuola particolare: non ufficialmente montessoriana ma che ne applicava gran parte dei metodi. Imparammo quasi tutti a leggere molto presto. C’erano solo tre classi in quella scuola, ma non erano divise per età, così i più grandi davano una mano ai più piccoli, si costruiva assieme, ci si imbrattava di vernice. Noi grandi leggevamo persino le storie ai piccoli, ma solo al pomeriggio.
Disegnavamo molti cavalli, io e Stefano. «Metti le sopracciglia» diceva lui. «I cavalli hanno le sopracciglia. Mettile, mi raccomando».
Le mettevamo entrambi, pelossisime. Sopracciglia importanti come quelle dei vecchi saggi dei cartoni animati.
Io invece ero bravo a disegnare le tigri fatte a pezzi. Ero bravo perché i pezzetti di tigre erano piccoli piccoli ma si riconosceva comunque che era un tigre. Un occhio di qua, uno di là, i denti, le orecchie, il muso, le zampette, divise in almeno tre o quattro frammenti, la coda anche di più, tutto sparpagliato sul foglio e con tanto sangue rosso che usciva da ogni parte. Non lo so mica perché le disegnavo. Non avevo visto nessun animale fatto a pezzi, a parte forse qualche insetto, ma in ogni caso non ci sarebbe stato sangue, comunque non rosso come il nostro. Non so neanche se la maestra ne parlò mai ai miei genitori, che tuttavia lo sapevano benissimo perché li portavo anche a casa quei disegni.
A un certo punto io e Stefano cominciammo a fare a pezzi pure i cavalli. Gli uomini invece no. Li facevamo muscolosissimi, solitamente in mutande, con gli addominali a tartaruga e tutto quanto, e li riempivamo di tagli e di schizzi di sangue ma li lasciavamo sempre con tutte le gambe e le braccia e la testa e gli occhi attaccati (ma quand'erano di profilo, in effetti, non si può mai sapere).
Appeso sopra al suo letto, Stefano aveva un ritratto di Gesù. Me lo spiegò lui che era Gesù perché io non lo sapevo: noi in famiglia non andavamo in chiesa, i miei non erano credenti e la mia prima preghiera — Atto di dolore, mio Dio mi pento e mi dolgo... mi piaceva tantissimo quella parola, dolgo — la recitai durante l’estate subito dopo la fine della prima elementare, quando mia zia Catia mi portò a catechismo e scoprii, tra l’altro, che tutti i miei compagni di scuola la domenica si vedevano lì.
Quello di Gesù era un quadretto piccolo, senza cornice, appeso con un gancino dorato. Sembrava esser stato dipinto direttamente sul legno. Il problema erano gli occhi: quel ritratto ti fissava. Lo faceva in modo strano, come nessun altro sguardo avessi visto fino a quel momento.
Chiesi a Stefano se poteva voltarlo. Intendevo dire proprio girarlo dall’altra parte, faccia al muro o, ancora meglio, toglierlo del tutto. Non mi faceva sentire bene che quegli occhi mi guardassero così. Stefano però non ci arrivava a toglierlo, probabilmente nemmeno salendo sul letto. E comunque, come con la storia dei cani, avendo l’occasione di spaventarmi, ovviamente la sfruttava. L’avrei fatto anch’io.
(Qualche anno dopo, quello stesso identico quadretto lo ritrovai in camera di Andrea, un mio amico delle elementari e poi anche delle medie. «Non ti fanno paura quegli occhi?», chiesi un pomeriggio ad Andrea dopo aver rimuginato quel pensiero per un po'. «No, perché?». E a quel punto cominciò pure lui a guardarli bene gli occhi di Gesù, e lo percepii benissimo il suo disagio. Sembrava scavarti fino in fondo al cervello, quello sguardo, e poi oltre. Pareva vedesse qualcosa di te che tu però non riuscivi a vedere. Andrea, a differenza di Stefano, lo voltò faccia al muro. Giocammo per un po’ ma a un certo punto i nostri pensieri tornarono lì, al quadro capovolto. Non vederlo, quello sguardo, era ancora peggio che averlo puntato in faccia, quasi potesse fare qualcosa a nostra insaputa. Quindi continuavamo a sbirciare lì sotto, sollevandolo un poco dal muro, per poi rimetterlo a posto e così via, finché non arrivò la madre di Andrea e ci sgridò perché «Non si gioca con Gesù». Quando tornai a casa mi chiesi come avrebbe fatto, Andrea, quella notte).
Stefano, pure, non so come facesse. Io non sarei mai riuscito a dormire con quello nella stanza. Né sapendo di averlo da qualche altra parte, tipo in salotto, in cucina, nella stanzetta.
«Saranno stati almeno dieci!», Stefano mi stava raccontando che un po’ di tempo prima un ragazzo del quartiere era stato attaccato dai cani.
Il ragazzo l’avevano ritrovato il giorno dopo, tra le colonne. Sbranato.
Sbranato.
E intanto gli ululati dei cani continuavano, mentre l'aria, di là, dai nostri genitori, si era fatta elettrica.
Chissà se il padre di Stefano aveva la grappa. Chissà se aveva le bottiglie impolverate e anche lui le avrebbe aperte quando sarebbe arrivata l'occasione. E chissà dove le teneva le bottiglie. E da dove sarebbe arrivata l'occasione. Chissà se con la spada di plastica sarei riuscito ad arrivare al quadretto di Gesù.
«Sei stanco?» chiese mia madre che era venuta a controllare. In effetti sì, ero stanco, ma non l’avrei mai ammesso perché speravo non dover mai uscire da quella casa, perlomeno non di notte, coi cani randagi che sbranavano.
Se li avessi avvertiti, i miei genitori, che avrebbero fatto? Saremmo rimasti tutti a dormire lì? Sarei riuscito anche a convincere qualcuno dei grandi a togliere Gesù?
Ma non ebbi il coraggio di dirlo alla mamma, che se tornò di là, dove ricominciarono a ridere. Avrei voluto che le risate continuassero per tutta la notte o perlomeno fin quando non mi fossi addormentato io. E credo che alla fine mi addormentai.
La stanza che ospitava la scala per anni non servì a niente. C'era una finestra che dava sul giardino, c'era un tavolo marrone chiaro, lucido, quadrato e con un cassetto, c'era un armadio porta scarpe e una libreria che dava sulla gabbia della scala. Lì tenevamo i libri di cucina, i manuali, il cestino del cucito. Dietro a uno sportello c’erano le medicine e dietro all'altro i giocattoli che usavo poco.
L’unica, effettiva funzione della stanza, nonostante fosse abbastanza grande da poterci mettere dentro un piccolo salotto o una camera da letto, era di ospitare la scala rossa che portava in garage. Di lì si scendeva giù di almeno tre metri e mezzo, forse quattro metri, e si arrivava a una piccola anticamera da cui, attraverso una porta, si entrava in garage.
Di sera, prima di andare a dormire, quella porta veniva chiusa rigorosamente a chiave, come pure la porta della stanza di sopra, quella della scala, che chiamavamo “la stanzetta”. Era molto importante che fossero chiuse entrambe e, se per caso capitava che qualcuno se ne dimenticasse, l'indomani mattina, a colazione, si faceva notare la svista non tanto con severità ma comunque con una certa fermezza. A un certo punto, quando mettemmo le inferriate su tutte le finestre della casa, e non molto tempo dopo mio padre comprò anche una pistola, laggiù, sulla porta che conduceva in garage, facemmo mettere un cancello a scorrimento orizzontale. Quando veniva chiuso, la sera, la chiave andava appoggiata XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX (mi spiace ma era ed è ancora un segreto di famiglia), il più lontano possibile dalla porta, sì che nessun umano sprovvisto di un bastone con su attaccata una calamita potesse arrivarci.
Succedeva, anche se molto raramente in effetti, di dover andare fin laggiù la sera dopocena o, peggio, in piena notte. Quando capitava, tutto quel girare di chiavi e far rotolare il cancello sui suoi binari, ripetuto per due volte, andata e ritorno, era quantomeno grottesco. E dal mio letto — io dormivo proprio di fronte alla stanzetta — tendevo l'orecchio e seguivo ogni singola fase di quell'insolito rituale, eseguito sempre e comunque con un misto di malavoglia, rapidità e cautela: seguivo ogni passo, ogni scricchiolio della scala, ogni serratura che scattava, e in quei momenti mi pareva di sentire il sapore del ferro della cancellata sulla lingua.
Comunque in garage, di notte, era meglio non andare, su questo concordavamo tutti.
Se per esempio c’era una cena e arrivavano ospiti, il cancello scorrevole là sotto veniva chiuso prima che arrivassero, ovviamente dopo aver portato su le bottiglie di vino necessarie. C’era un’intera parete piena di nicchie rotonde e regolari, laggiù, ciascuna larga quanto una bottiglia, e di bottiglie ne avevamo tante, tra cui alcune piene di polvere che erano lì da chissà quanto e che mio padre qualche volta, quando c’ero anche io, prendeva, leggeva le etichette, fantasticava su chissà cosa e poi le rimetteva a posto, dicendo: «Questa la apriamo per un occasione speciale».
Se la cena con gli ospiti andava particolarmente bene e tutto il vino in cucina finiva, oppure l’atmosfera era tanto elettrica da meritare che venisse aperta una delle bottiglie di grappa speciali, allora bisognava scendere giù, aprire il cancello, accendere la luce, sempre con rapidità, sempre con cautela, e risalire in fretta dopo aver chiuso. Quando succedeva sia io che mia madre stavamo con le orecchie ben diritte, per captare ogni rumore, finché mio padre non risaliva. Gli ospiti, che non lo sapevano, probabilmente giudicavano buffo il nostro modo di comportarci, ma di solito a quel punto avevano già bevuto e non ci facevano caso. Se c’erano anche bambini, loro se ne accorgevano, tranne se erano proprio piccoli piccoli.
Una volta Stefano me lo chiese: «Che c’è di sotto?».
Stefano era quello che una volta, quando coi miei andammo a cena a casa sua, mi raccontò che nel suo isolato di notte andava in giro un branco di cani randagi. Questi cani erano grossi e attaccavano le persone. Si sentiva pure ululare, in effetti, proprio mentre lui me lo diceva.
«State attenti quando andate a casa» disse quando io e lui giocavamo, da soli, in camera sua, mentre i grandi erano di là, oltre il corridoio, che ridevano.
Io e Stefano a scuola ci mettevamo spesso vicini a disegnare. Era una scuola particolare: non ufficialmente montessoriana ma che ne applicava gran parte dei metodi. Imparammo quasi tutti a leggere molto presto. C’erano solo tre classi in quella scuola, ma non erano divise per età, così i più grandi davano una mano ai più piccoli, si costruiva assieme, ci si imbrattava di vernice. Noi grandi leggevamo persino le storie ai piccoli, ma solo al pomeriggio.
Disegnavamo molti cavalli, io e Stefano. «Metti le sopracciglia» diceva lui. «I cavalli hanno le sopracciglia. Mettile, mi raccomando».
Le mettevamo entrambi, pelossisime. Sopracciglia importanti come quelle dei vecchi saggi dei cartoni animati.
Io invece ero bravo a disegnare le tigri fatte a pezzi. Ero bravo perché i pezzetti di tigre erano piccoli piccoli ma si riconosceva comunque che era un tigre. Un occhio di qua, uno di là, i denti, le orecchie, il muso, le zampette, divise in almeno tre o quattro frammenti, la coda anche di più, tutto sparpagliato sul foglio e con tanto sangue rosso che usciva da ogni parte. Non lo so mica perché le disegnavo. Non avevo visto nessun animale fatto a pezzi, a parte forse qualche insetto, ma in ogni caso non ci sarebbe stato sangue, comunque non rosso come il nostro. Non so neanche se la maestra ne parlò mai ai miei genitori, che tuttavia lo sapevano benissimo perché li portavo anche a casa quei disegni.
A un certo punto io e Stefano cominciammo a fare a pezzi pure i cavalli. Gli uomini invece no. Li facevamo muscolosissimi, solitamente in mutande, con gli addominali a tartaruga e tutto quanto, e li riempivamo di tagli e di schizzi di sangue ma li lasciavamo sempre con tutte le gambe e le braccia e la testa e gli occhi attaccati (ma quand'erano di profilo, in effetti, non si può mai sapere).
Appeso sopra al suo letto, Stefano aveva un ritratto di Gesù. Me lo spiegò lui che era Gesù perché io non lo sapevo: noi in famiglia non andavamo in chiesa, i miei non erano credenti e la mia prima preghiera — Atto di dolore, mio Dio mi pento e mi dolgo... mi piaceva tantissimo quella parola, dolgo — la recitai durante l’estate subito dopo la fine della prima elementare, quando mia zia Catia mi portò a catechismo e scoprii, tra l’altro, che tutti i miei compagni di scuola la domenica si vedevano lì.
Quello di Gesù era un quadretto piccolo, senza cornice, appeso con un gancino dorato. Sembrava esser stato dipinto direttamente sul legno. Il problema erano gli occhi: quel ritratto ti fissava. Lo faceva in modo strano, come nessun altro sguardo avessi visto fino a quel momento.
Chiesi a Stefano se poteva voltarlo. Intendevo dire proprio girarlo dall’altra parte, faccia al muro o, ancora meglio, toglierlo del tutto. Non mi faceva sentire bene che quegli occhi mi guardassero così. Stefano però non ci arrivava a toglierlo, probabilmente nemmeno salendo sul letto. E comunque, come con la storia dei cani, avendo l’occasione di spaventarmi, ovviamente la sfruttava. L’avrei fatto anch’io.
(Qualche anno dopo, quello stesso identico quadretto lo ritrovai in camera di Andrea, un mio amico delle elementari e poi anche delle medie. «Non ti fanno paura quegli occhi?», chiesi un pomeriggio ad Andrea dopo aver rimuginato quel pensiero per un po'. «No, perché?». E a quel punto cominciò pure lui a guardarli bene gli occhi di Gesù, e lo percepii benissimo il suo disagio. Sembrava scavarti fino in fondo al cervello, quello sguardo, e poi oltre. Pareva vedesse qualcosa di te che tu però non riuscivi a vedere. Andrea, a differenza di Stefano, lo voltò faccia al muro. Giocammo per un po’ ma a un certo punto i nostri pensieri tornarono lì, al quadro capovolto. Non vederlo, quello sguardo, era ancora peggio che averlo puntato in faccia, quasi potesse fare qualcosa a nostra insaputa. Quindi continuavamo a sbirciare lì sotto, sollevandolo un poco dal muro, per poi rimetterlo a posto e così via, finché non arrivò la madre di Andrea e ci sgridò perché «Non si gioca con Gesù». Quando tornai a casa mi chiesi come avrebbe fatto, Andrea, quella notte).
Stefano, pure, non so come facesse. Io non sarei mai riuscito a dormire con quello nella stanza. Né sapendo di averlo da qualche altra parte, tipo in salotto, in cucina, nella stanzetta.
«Saranno stati almeno dieci!», Stefano mi stava raccontando che un po’ di tempo prima un ragazzo del quartiere era stato attaccato dai cani.
Il ragazzo l’avevano ritrovato il giorno dopo, tra le colonne. Sbranato.
Sbranato.
E intanto gli ululati dei cani continuavano, mentre l'aria, di là, dai nostri genitori, si era fatta elettrica.
Chissà se il padre di Stefano aveva la grappa. Chissà se aveva le bottiglie impolverate e anche lui le avrebbe aperte quando sarebbe arrivata l'occasione. E chissà dove le teneva le bottiglie. E da dove sarebbe arrivata l'occasione. Chissà se con la spada di plastica sarei riuscito ad arrivare al quadretto di Gesù.
«Sei stanco?» chiese mia madre che era venuta a controllare. In effetti sì, ero stanco, ma non l’avrei mai ammesso perché speravo non dover mai uscire da quella casa, perlomeno non di notte, coi cani randagi che sbranavano.
Se li avessi avvertiti, i miei genitori, che avrebbero fatto? Saremmo rimasti tutti a dormire lì? Sarei riuscito anche a convincere qualcuno dei grandi a togliere Gesù?
Ma non ebbi il coraggio di dirlo alla mamma, che se tornò di là, dove ricominciarono a ridere. Avrei voluto che le risate continuassero per tutta la notte o perlomeno fin quando non mi fossi addormentato io. E credo che alla fine mi addormentai.
Il tavolo liscio
Ne avevano parlato davanti a una bottiglia d’acqua, di quelle da mezzo litro, unico totem al centro esatto del tavolo, come un tranquillo occhio del ciclone mentre tutto attorno volavano raffiche di frustrazione. Lei avrebbe voluto che. Lui non pensava di. Lei sapeva benissimo (e non da adesso, erano giorni che ci rimuginava su, rivelò a un certo punto) ma non poteva immaginare come poi.
Soltanto quando uno dei due batteva una mano sul tavolo, in maniera così teatrale da risultare quasi insopportabile, la superficie dell’acqua nella bottiglietta si increspava a formare una specie di piccola onda che, finché non tornava allo stato di quiete, catalizzava lo sguardo di entrambi e aveva il potere di sospendere, seppur temporaneamente, le ostilità, tanto che entrambi, esausti dal dover spiegare quel che sapevano benissimo non c’era per niente bisogno di spiegare (era il senso del dovere a incastrarli, l’ossessione per la trasparenza diventava una lama a doppio taglio quando c’era da litigare), speravano ciascuno in cuor proprio che l’onda in miniatura andasse avanti per sempre, intrappolata in quei pochi grammi di PET riciclabile prodotti da qualche oscuro macchinario in uno stabilimento di Rionero Vulture (PZ) — lui aveva trovato il tempo di leggere e rileggere l’etichetta mentre lei lanciava le sue accuse: stava dal suo lato, l’etichetta intendo, e, accarezzandosi la barba come faceva sempre quando si sentiva in stallo, lui aveva provato pure ad aggrapparsi a quel toponimo capitato lì per caso per evadere da quel momento, un’evasione in solitaria dato che lei, che stava dall’altra parte dell’etichetta e l’unico appiglio che aveva erano le liquide oscillazioni prima della bonaccia in bottiglia, (difficilmente Rionero, cap 85028, avrebbe potuto materializzarsi nei suoi pensieri senza l’aiuto di un po’ di telepatia), non avrebbe mai potuto appendersi allo stesso filo di pensieri che lui stava cercando di acchiappare al volo, planando a volo d’uccello su una mappa stile Google materializzatasi d’improvviso tra un «dovevi dirmelo» e un «avrei capito» di lei, intravedendo già un’anonima zona industriale circondata da uno scenario agreste, capannoni grigi, tetti piatti, una stradina che collegava lo stabilimento alla provinciale, l’insegna FONTI DEL VULTURE S.R.L. in blu marino, i camion nel piazzale, ma poi lei aveva battuto di nuovo (per rimettere in moto lo sciabordio e regalarsi un’altra piccola tregua, ma lui non lo sapeva e d’istinto registrò le ultime parole di lei, «anche io, che ti pare?», credendo che stesse sottolineandole), riportandolo su quel tavolo troppo liscio, povero di topografie, praticamente immune dai segni e dalle asperità che una (sentiva di poterlo scrivere solo tra virgolette) ”vera“ vita di coppia lascia sugli oggetti, e gli venne in mente che forse quel tavolo liscio potesse essere una metafora perfetta del rapporto che avevano costruito, di comune accordo pur senza mai esplicitarne le regole (perché andava bene così, perché loro erano così, e forse si erano trovati anche per questo), anche se la parola giusta, pensò, forse era “arredato”, come quelle stanze intonse e perfette nelle riviste di arredamento, come se su quel loro stare assieme fosse passato uno stylist a dare gli ultimi ritocchi (queste sono le persone che dovete frequentare, ecco le serie tv di cui dovete parlare, qua c’è un rancore di troppo che va messo fuori scena, sì, lì nello sgabuzzino va bene) per poi andarsene da qualche altro cliente, lasciandoli lì, sulla ribalta di una messa in scena, con in mano un copione dettagliatissimo che non lascia via d’uscita, e una volta arrivato alla fine ricomincia daccapo, ripetendosi in un loop, ma strappando sensazionali applausi al pubblico di cartapesta che dopotutto sa fare solo quello e.
«Ci hai mai pensato? Eh? Ci hai mai pensato?», chiese lei strappandolo via dal proscenio, con le dita accarezzando la superficie del tavolo, solida e rassicurante nel suo essere quasi impeccabile, andando a cercare, con la punta dell’indice, quella riga quasi invisibile, quella riga che aveva fatto lui, col coltello del pane, quella volta che.
Soltanto quando uno dei due batteva una mano sul tavolo, in maniera così teatrale da risultare quasi insopportabile, la superficie dell’acqua nella bottiglietta si increspava a formare una specie di piccola onda che, finché non tornava allo stato di quiete, catalizzava lo sguardo di entrambi e aveva il potere di sospendere, seppur temporaneamente, le ostilità, tanto che entrambi, esausti dal dover spiegare quel che sapevano benissimo non c’era per niente bisogno di spiegare (era il senso del dovere a incastrarli, l’ossessione per la trasparenza diventava una lama a doppio taglio quando c’era da litigare), speravano ciascuno in cuor proprio che l’onda in miniatura andasse avanti per sempre, intrappolata in quei pochi grammi di PET riciclabile prodotti da qualche oscuro macchinario in uno stabilimento di Rionero Vulture (PZ) — lui aveva trovato il tempo di leggere e rileggere l’etichetta mentre lei lanciava le sue accuse: stava dal suo lato, l’etichetta intendo, e, accarezzandosi la barba come faceva sempre quando si sentiva in stallo, lui aveva provato pure ad aggrapparsi a quel toponimo capitato lì per caso per evadere da quel momento, un’evasione in solitaria dato che lei, che stava dall’altra parte dell’etichetta e l’unico appiglio che aveva erano le liquide oscillazioni prima della bonaccia in bottiglia, (difficilmente Rionero, cap 85028, avrebbe potuto materializzarsi nei suoi pensieri senza l’aiuto di un po’ di telepatia), non avrebbe mai potuto appendersi allo stesso filo di pensieri che lui stava cercando di acchiappare al volo, planando a volo d’uccello su una mappa stile Google materializzatasi d’improvviso tra un «dovevi dirmelo» e un «avrei capito» di lei, intravedendo già un’anonima zona industriale circondata da uno scenario agreste, capannoni grigi, tetti piatti, una stradina che collegava lo stabilimento alla provinciale, l’insegna FONTI DEL VULTURE S.R.L. in blu marino, i camion nel piazzale, ma poi lei aveva battuto di nuovo (per rimettere in moto lo sciabordio e regalarsi un’altra piccola tregua, ma lui non lo sapeva e d’istinto registrò le ultime parole di lei, «anche io, che ti pare?», credendo che stesse sottolineandole), riportandolo su quel tavolo troppo liscio, povero di topografie, praticamente immune dai segni e dalle asperità che una (sentiva di poterlo scrivere solo tra virgolette) ”vera“ vita di coppia lascia sugli oggetti, e gli venne in mente che forse quel tavolo liscio potesse essere una metafora perfetta del rapporto che avevano costruito, di comune accordo pur senza mai esplicitarne le regole (perché andava bene così, perché loro erano così, e forse si erano trovati anche per questo), anche se la parola giusta, pensò, forse era “arredato”, come quelle stanze intonse e perfette nelle riviste di arredamento, come se su quel loro stare assieme fosse passato uno stylist a dare gli ultimi ritocchi (queste sono le persone che dovete frequentare, ecco le serie tv di cui dovete parlare, qua c’è un rancore di troppo che va messo fuori scena, sì, lì nello sgabuzzino va bene) per poi andarsene da qualche altro cliente, lasciandoli lì, sulla ribalta di una messa in scena, con in mano un copione dettagliatissimo che non lascia via d’uscita, e una volta arrivato alla fine ricomincia daccapo, ripetendosi in un loop, ma strappando sensazionali applausi al pubblico di cartapesta che dopotutto sa fare solo quello e.
«Ci hai mai pensato? Eh? Ci hai mai pensato?», chiese lei strappandolo via dal proscenio, con le dita accarezzando la superficie del tavolo, solida e rassicurante nel suo essere quasi impeccabile, andando a cercare, con la punta dell’indice, quella riga quasi invisibile, quella riga che aveva fatto lui, col coltello del pane, quella volta che.
Il peso della Terra è sempre lo stesso
Chiudere gli occhi. Ma non prima di aver chiuso: la porta, due mandate la chiave piccola, quattro la grande, giù pure il coperchio dello spioncino, ruotarlo in senso anti-orario; le persiane e le finestre, sei in tutto, chiudi-chiudi, chiudi-chiudi, chiudi-chiudi, tira le tende; il rubinetto del gas, anti-orario; il rubinetto generale dell’acqua, orario, poi far uscire quella rimasta - doccia, cucina, bagno; interruttore generale della luce, giù, tlak.
Spegnere il cellulare. Finalmente. Chiudere gli occhi. Nessun rumore, a parte il cuore che batte. A parte il respiro. Che rallenta. Lo stomaco borbotta e la casa scricchiola. Le pareti più del soffitto. Sono seduta al centro della stanza e la stanza è il salotto. Ho tolto il divano, che ora è in cucina, ho tolto il tavolo da pranzo, che ora è in camera. Ho tolto il mobile della tv, la libreria, le mensole con gli orologi, i quadri alle pareti, la polvere dagli angoli, i battiscopa. Ho stuccato i buchi dei chiodi e dei tasselli. Stuccato ogni singola ferita dell’intonaco. Ho spazzato il pavimento e messo la coperta quadrata al centro esatto, parallela e perpendicolare alle pareti. Ho tolto le batterie da telecomandi e sveglie, buttato la spazzatura e scritto il mio cognome, con pennarello, su tutti i sacchetti. nel sacco dell’indifferenziata ho messo pure i vestiti. Calze, mutande, jeans, reggipetto, maglietta, camicia, maglioncino di cotone. Giallo senape. le scarpe fuori dalla porta d’ingresso. Un biglietto per la vicina infilato in quella destra. Uno per il postino in quella sinistra. Identici. Su entrambi ho scritto: non disturbar. Senza la e. Mi piaceva così. E sotto: la mia iniziale, la S.
È il 28 febbraio e vedo anche al buio. Intuisco le forme ma ne non percepisco i volumi, disturbate come sono dal fruscio percettivo. Sembra di stare in un campo di battaglia di pixel sconfitti dalla vittoria delle tenebre, che però non vogliono rassegnarsi a spegnersi per sempre. Oltre allo zero e all’uno c’è il lampeggiare della memoria dell’uno. Chiudere gli occhi o tenerli aperti è uguale? Si riesce a dormire con le palpebre alzate? Mi tocco la palpebra destra. La apro e provo a toccarmi l’occhio, a vivo, ma non ci riesco.
Dovrei iniziare a percepire l’oceano di energia cosmica. Così diceva il libro. Provo a far ondeggiare un po’ le braccia. Tengo gli avambracci sollevati, come fossero sul pelo dell’acqua. La parte interna degli avambracci è delicata, oltre che più chiara del resto. Riesco a sentirle le onde di energia che mi scorrono sotto alle dita? Ho sempre immaginato il buio totale come una massa viscosa è invece è un blocco asciutto, polveroso, che ti secca la lingua e i polpastrelli. Sento il freddo del pavimento attraverso la coperta. Le natiche vanno addormentandosi sotto al peso del corpo. La pancia non sembra più la mia. Non la riconosco, al tatto. Provo ad uscire dal confine della coperta con le dita dei piedi. Due squadre di vermi che s’avventurano nella notte. A cinque a cinque si allargano e serrano le fila all’unisono, avanzando lentamente, bloccandosi un istante prima di portarsi dietro pure i talloni.
In ascolto. Più con il corpo che con l’orecchio. Il pavimento emette vibrazioni basse e quasi impercettibili. Il mondo è in comunicazione totale con se stesso. Non c’è niente che se ne stia separato da tutto il resto. Non a lungo, almeno. Il tempo che ci mette una foglia a cadere, un volo intercontinentale ad atterrare o a finire in pezzi in mezzo all’oceano, una goccia d’acqua a evaporare e a ricadere in qualche altra parte del pianeta in forma di rugiada, pioggia, grandine o neve.
Il peso della Terra è sempre lo stesso. L’ho letto da qualche parte. Miliardi di nuovi umani prendono il posto dei vecchi che la terra prima raccoglie poi consuma e trasforma. L’unica materia estranea è quella che arriva dallo spazio sotto forma di minuscoli frammenti di roccia. Quasi volessimo equilibrare il dono celeste di tanto in tanto fabbrichiamo qualcosa e lo spediamo fuori dall’atmosfera, parcheggiato sulla luna o in costante monitoraggio in orbita sopra alle nostre teste. C’è almeno un satellite a sapere che io sono qui? Mi vede, nuda, alzare e abbassare le spalle a ritmo con il respiro che va rallentando? E se mi vede, c’è qualcuno che controlla le immagini? Un allarme starà suonando da qualche parte? Una tizia nuda al buio, forse vuole uccidersi. Attivare lo zoom a visione notturna. Età tra i trenta e i quarantacinque, capelli corti, neri o castani scuri, abbronzata o mulatta. All’indirizzo corrisponde un nominativo maschile. C’è un numero di telefono. Risulta staccato. È intestato a lui pure quello. Andrea Guder, nato a Gorizia il 6.10.1967, morto ad Alberta, Australia, il 6 dicembre dell’anno scorso. Ultima residenza: l’indirizzo dell’appartamento in questione. I Carabinieri saranno sul posto tra venti minuti. Abbiamo allertato anche pompieri e ambulanza.
Ecco, ora anche i talloni sono usciti dal confine. Si appiccicano al pavimento e si staccano con un sottilissimo rumore di pelle mentre seguono le dita che avanzano come bruchi.
Spegnere il cellulare. Finalmente. Chiudere gli occhi. Nessun rumore, a parte il cuore che batte. A parte il respiro. Che rallenta. Lo stomaco borbotta e la casa scricchiola. Le pareti più del soffitto. Sono seduta al centro della stanza e la stanza è il salotto. Ho tolto il divano, che ora è in cucina, ho tolto il tavolo da pranzo, che ora è in camera. Ho tolto il mobile della tv, la libreria, le mensole con gli orologi, i quadri alle pareti, la polvere dagli angoli, i battiscopa. Ho stuccato i buchi dei chiodi e dei tasselli. Stuccato ogni singola ferita dell’intonaco. Ho spazzato il pavimento e messo la coperta quadrata al centro esatto, parallela e perpendicolare alle pareti. Ho tolto le batterie da telecomandi e sveglie, buttato la spazzatura e scritto il mio cognome, con pennarello, su tutti i sacchetti. nel sacco dell’indifferenziata ho messo pure i vestiti. Calze, mutande, jeans, reggipetto, maglietta, camicia, maglioncino di cotone. Giallo senape. le scarpe fuori dalla porta d’ingresso. Un biglietto per la vicina infilato in quella destra. Uno per il postino in quella sinistra. Identici. Su entrambi ho scritto: non disturbar. Senza la e. Mi piaceva così. E sotto: la mia iniziale, la S.
È il 28 febbraio e vedo anche al buio. Intuisco le forme ma ne non percepisco i volumi, disturbate come sono dal fruscio percettivo. Sembra di stare in un campo di battaglia di pixel sconfitti dalla vittoria delle tenebre, che però non vogliono rassegnarsi a spegnersi per sempre. Oltre allo zero e all’uno c’è il lampeggiare della memoria dell’uno. Chiudere gli occhi o tenerli aperti è uguale? Si riesce a dormire con le palpebre alzate? Mi tocco la palpebra destra. La apro e provo a toccarmi l’occhio, a vivo, ma non ci riesco.
Dovrei iniziare a percepire l’oceano di energia cosmica. Così diceva il libro. Provo a far ondeggiare un po’ le braccia. Tengo gli avambracci sollevati, come fossero sul pelo dell’acqua. La parte interna degli avambracci è delicata, oltre che più chiara del resto. Riesco a sentirle le onde di energia che mi scorrono sotto alle dita? Ho sempre immaginato il buio totale come una massa viscosa è invece è un blocco asciutto, polveroso, che ti secca la lingua e i polpastrelli. Sento il freddo del pavimento attraverso la coperta. Le natiche vanno addormentandosi sotto al peso del corpo. La pancia non sembra più la mia. Non la riconosco, al tatto. Provo ad uscire dal confine della coperta con le dita dei piedi. Due squadre di vermi che s’avventurano nella notte. A cinque a cinque si allargano e serrano le fila all’unisono, avanzando lentamente, bloccandosi un istante prima di portarsi dietro pure i talloni.
In ascolto. Più con il corpo che con l’orecchio. Il pavimento emette vibrazioni basse e quasi impercettibili. Il mondo è in comunicazione totale con se stesso. Non c’è niente che se ne stia separato da tutto il resto. Non a lungo, almeno. Il tempo che ci mette una foglia a cadere, un volo intercontinentale ad atterrare o a finire in pezzi in mezzo all’oceano, una goccia d’acqua a evaporare e a ricadere in qualche altra parte del pianeta in forma di rugiada, pioggia, grandine o neve.
Il peso della Terra è sempre lo stesso. L’ho letto da qualche parte. Miliardi di nuovi umani prendono il posto dei vecchi che la terra prima raccoglie poi consuma e trasforma. L’unica materia estranea è quella che arriva dallo spazio sotto forma di minuscoli frammenti di roccia. Quasi volessimo equilibrare il dono celeste di tanto in tanto fabbrichiamo qualcosa e lo spediamo fuori dall’atmosfera, parcheggiato sulla luna o in costante monitoraggio in orbita sopra alle nostre teste. C’è almeno un satellite a sapere che io sono qui? Mi vede, nuda, alzare e abbassare le spalle a ritmo con il respiro che va rallentando? E se mi vede, c’è qualcuno che controlla le immagini? Un allarme starà suonando da qualche parte? Una tizia nuda al buio, forse vuole uccidersi. Attivare lo zoom a visione notturna. Età tra i trenta e i quarantacinque, capelli corti, neri o castani scuri, abbronzata o mulatta. All’indirizzo corrisponde un nominativo maschile. C’è un numero di telefono. Risulta staccato. È intestato a lui pure quello. Andrea Guder, nato a Gorizia il 6.10.1967, morto ad Alberta, Australia, il 6 dicembre dell’anno scorso. Ultima residenza: l’indirizzo dell’appartamento in questione. I Carabinieri saranno sul posto tra venti minuti. Abbiamo allertato anche pompieri e ambulanza.
Ecco, ora anche i talloni sono usciti dal confine. Si appiccicano al pavimento e si staccano con un sottilissimo rumore di pelle mentre seguono le dita che avanzano come bruchi.
La felicità la misuravamo in finestre
Tredici finestre, avevamo. Undici normali e due porte-finestre. Prima che cominciassero a farsi costruire ville moderniste con enormi finestroni che si aprono lungo tutta la parete, la felicità la misuravamo così, in finestre. Con due, tre finestre eri triste e povero. Una porta-finestra, affacciandosi su un balcone — per quanto piccolo — o un cortile — per quanto angusto, buio, pieno di cicche di sigaretta e cacatine di piccione—valeva come una piccola appendice di allegria. Dalle dieci finestre in su potevi considerarti fortunato e felice. Potevi dire di avere una vita piena. Di luce e di finestre.
Dieci finestre significavano almeno due bagni. Un salotto o una cucina luminosi. Magari entrambi, e un bello studio, se decidevi di non metter su troppa prole. Forse pure una stanza per gli ospiti (la suocera, l’ex-compagno di università, l’amica teatrante e libertina di tua moglie). Oppure una stanza-lavanderia. per non parlare della possibilità di una stanza-guardaroba: chi non si ecciterebbe alla sola idea di camicie che trascendono i confini dell'armadio per conquistare pareti e metriquadri?
E uno specchio: per controllare, al mattino, la tenuta del corpo, dopo tutti quegli anni passati a lavorare sodo, tra riunioni, serate in ufficio, aperitivi, due settimane in riviera, d'estate, coi genitori di lei.
Sopra alle dodici finestre poteva significare che c'era una mansarda, e lì si entrava nel regno delle finestrelle vista cielo e della fantasia. Che potevi metterci in una mansarda? Un tavolo da biliardo? Il bersaglio delle freccette? I videogame da sala giochi come ne Il mio amico Ricky? Un mobile bar! Perché non un mobile bar? Tutto in legno, coi bicchieri che pendono dall'alto, a testa in giù, pronti per esser disseminati dappertutto alla prima occasione. E dopo la festa, la tua prima festa in mansarda, ritrovarli sotto al biliardo, dietro al sofà, persino al gabinetto (perché l'hai fatto mettere il gabinetto in mansarda, senza finestre ma con un bel lavandino e uno specchio che chissà come dava a tutti un'aria funebre): bicchieri ancora pieni, bicchieri usati come posacenere, bicchieri con le tracce di rossetto. Chinandoti a raccoglierli, portarteli poi al naso per sentire il profumo del gin misto alle labbra, quelle labbra. Le labbra che hai assaggiato una volta sola, quel giorno in cui l'azienda era chiusa per l'inventario e suo marito era fuori per lavoro e i bambini a scuola e dovevi solo riportare la teglia dello sformato, solo quella — vai tu, io ho da fare qua, ci metti solo due minuti, aveva detto Sara mentre eri ancora a letto. Quel mercoledì libero, piovuto dal nulla come un regalo, avevi deciso di consacrarlo alla noia. Ma ti sei alzato. Sei andato a lavarti, in bagno (una sola finestra ma orientata est, per aver il sole diretto ogni mattina). Ti sei specchiato, nella stanza guardaroba (altra finestra a est), hai tirato in dentro quel poco di pancia che aveva cominciato a spuntar fuori un paio di anni prima e che non voleva andarsene, nonostante le corse, la sera, quando riuscivi a ritagliarti il tempo per girare attorno al quartiere e sudare, in calzoncini, guardando le case degli altri — Manoni, dodici finestre; Onorato, diciotto, di cui ben quattro porte-finestre e quella terrazza enorme che guarda tutti dall'alto in basso; Giacometti, quindici; Brisa, otto (chissà per quanto); Vitali, lassù sulla sua collinetta con quella squadrata fortezza modernista; Albertoni, dodici finestre; De Luca...
Dieci finestre significavano almeno due bagni. Un salotto o una cucina luminosi. Magari entrambi, e un bello studio, se decidevi di non metter su troppa prole. Forse pure una stanza per gli ospiti (la suocera, l’ex-compagno di università, l’amica teatrante e libertina di tua moglie). Oppure una stanza-lavanderia. per non parlare della possibilità di una stanza-guardaroba: chi non si ecciterebbe alla sola idea di camicie che trascendono i confini dell'armadio per conquistare pareti e metriquadri?
E uno specchio: per controllare, al mattino, la tenuta del corpo, dopo tutti quegli anni passati a lavorare sodo, tra riunioni, serate in ufficio, aperitivi, due settimane in riviera, d'estate, coi genitori di lei.
Sopra alle dodici finestre poteva significare che c'era una mansarda, e lì si entrava nel regno delle finestrelle vista cielo e della fantasia. Che potevi metterci in una mansarda? Un tavolo da biliardo? Il bersaglio delle freccette? I videogame da sala giochi come ne Il mio amico Ricky? Un mobile bar! Perché non un mobile bar? Tutto in legno, coi bicchieri che pendono dall'alto, a testa in giù, pronti per esser disseminati dappertutto alla prima occasione. E dopo la festa, la tua prima festa in mansarda, ritrovarli sotto al biliardo, dietro al sofà, persino al gabinetto (perché l'hai fatto mettere il gabinetto in mansarda, senza finestre ma con un bel lavandino e uno specchio che chissà come dava a tutti un'aria funebre): bicchieri ancora pieni, bicchieri usati come posacenere, bicchieri con le tracce di rossetto. Chinandoti a raccoglierli, portarteli poi al naso per sentire il profumo del gin misto alle labbra, quelle labbra. Le labbra che hai assaggiato una volta sola, quel giorno in cui l'azienda era chiusa per l'inventario e suo marito era fuori per lavoro e i bambini a scuola e dovevi solo riportare la teglia dello sformato, solo quella — vai tu, io ho da fare qua, ci metti solo due minuti, aveva detto Sara mentre eri ancora a letto. Quel mercoledì libero, piovuto dal nulla come un regalo, avevi deciso di consacrarlo alla noia. Ma ti sei alzato. Sei andato a lavarti, in bagno (una sola finestra ma orientata est, per aver il sole diretto ogni mattina). Ti sei specchiato, nella stanza guardaroba (altra finestra a est), hai tirato in dentro quel poco di pancia che aveva cominciato a spuntar fuori un paio di anni prima e che non voleva andarsene, nonostante le corse, la sera, quando riuscivi a ritagliarti il tempo per girare attorno al quartiere e sudare, in calzoncini, guardando le case degli altri — Manoni, dodici finestre; Onorato, diciotto, di cui ben quattro porte-finestre e quella terrazza enorme che guarda tutti dall'alto in basso; Giacometti, quindici; Brisa, otto (chissà per quanto); Vitali, lassù sulla sua collinetta con quella squadrata fortezza modernista; Albertoni, dodici finestre; De Luca...